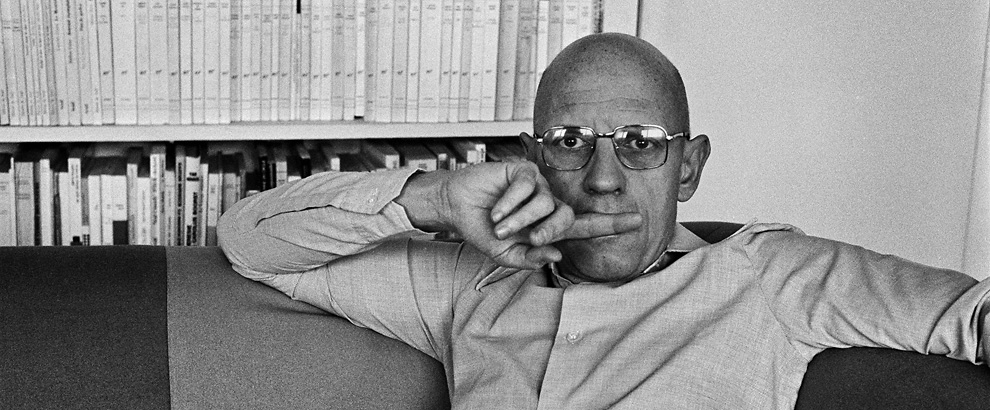
1. Verità e delirio
Comincerò con un bozzetto clinico redatto dal dottor Charpentier, relativo a un paziente malinconico (C.A.T. Charpentier, Essai sur la mélancolie, Paris 1804):
Un curato di 58 anni [X], di costituzione robusta, conduceva prima della rivoluzione una vita molto attiva. All’inizio della rivoluzione si pronuncia per la riforma dell’alto clero; ma resta molto impressionato dagli eccessi della rivoluzione e dalla totale distruzione della religione. Perde diverse somme che aveva investito. Le chiese sono riaperte per divenire ben presto dei templi di decadì. Il signor [X] cade allora nella più grave malinconia. Diventa cupo, taciturno, non vuole più mangiare. Si accusa di aver commesso dei crimini orribili; non sperando nella misericordia divina, afferma che godere della vita è una scelleratezza indegna. Si precipita in un pozzo. Persuaso che tutti conoscano la sua vicenda, non osa farsi vedere. Dietro sollecitazione dei suoi amici, partecipa come tutti alla vita di società. Appena è solo, le idee di disperazione si impadroniscono di lui. Dopo esser rimasto a letto per quindici giorni, si precipita una seconda volta nel medesimo pozzo. Qualche tempo dopo, stesso infortunio. Rimane in questo stato per due anni.
Gli vengono portati gli articoli portanti del concordato. Subito dopo la lettura di questo documento il signor [X] corre ovunque, vede i suoi amici, annuncia loro la sua guarigione. In effetti, da quell’epoca gode di una salute perfetta.
[Brano citato in: E. D. Esquirol, Delle passioni, a cura di Mario Galzigna, Marsilio, Venezia 1982, pp. 138-139].
Questo passo è tratto dalla thèse di dottorato presentata da Étienne Dominique Esquirol alla Facoltà medica di Parigi il 7 Nivoso dell’Anno 14 [Des Passions, considérées comme Causes, Symptômes et Moyens curatifs de l’Aliénation mentale, Paris, Imprimerie Didot Jeune, An XIV (1805), pp. 76-77]: uno dei testi inaugurali della psichiatria nascente, costruito a partire dal materiale clinico che il giovane Esquirol aveva raccolto nella sua clinica privata parigina di rue de Buffon, situata di fronte alla Salpêtrière.
Davvero sorprendente la descrizione di Charpentier citata da Esquirol: agli albori della psichiatria clinica emerge con chiarezza una malinconia percepita come patologia della perdita, come disagio connesso a un profondo smarrimento identitario, direttamente collegato ai grandi sommovimenti dell’età rivoluzionaria.
Angoscia della perdita, dunque, sentimento di colpa, autoaccusa, delirio, sradicamento sociale, tentato suicidio e infine una repentina quanto stupefacente “guarigione”, direttamente evocata e messa in scena nel testo: una guarigione conseguente all’iniziativa dei curanti volta a sopprimere il sintomo; un’iniziativa grazie alla quale il paziente ha potuto leggere gli articoli della legge concordataria che smentiscono e delegittimano le sue paure e le sue angosce.
Un gesto terapeutico autoritario interviene energicamente, qui, proprio a sanare quella frattura tra mondo interno e mondo esterno che stava all’origine della deriva patologica: un gesto che pretende di restituire al soggetto internato la sua capacità di produrre, per dirla con il linguaggio della clinica attuale, un corretto esame di realtà, sradicando così l’intero impianto della costruzione delirante. Un gesto che mette in scena l’alienista e le sue tecniche di intervento attivo sul paziente e sui suoi deliri: l’alienista, dunque, come incontrastato “signore della realtà”, che riesce ad imporsi proprio perché supportato dall’ordine disciplinare vigente nell’asilo. [Cfr. M. Foucault, Il potere psichiatrico, Feltrinelli, Milano 2004, p. 127; questa edizione italiana verrà in seguito richiamata con le iniziali PPI, seguìte dai numeri delle pagine].
È uno snodo cruciale, questo, della clinica psichiatrica, ieri come oggi: ieri come oggi la terapia punta a ricostruire, in svariate maniere, la perduta corrispondenza tra io e mondo, tra mondo interno e mondo esterno, tra rappresentazioni psichiche ed assetti di realtà. Varie sono, fin dal primo ottocento, le modalità attraverso le quali si cerca di sanare questa frattura sconvolgente e spesso abissale. Il potere psichiatrico è il testo delle lezioni tenute da Michel Foucault al Collège de France (anno accademico 1973-1974), dove queste modalità vengono puntigliosamente descritte e commentate
[cfr. M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique, Gallimard-Seuil, Paris 2003: questa edizione verrà in sèguito richiamata con le iniziali PPF, seguìte dai numeri delle pagine].
Un testo “orale” – sbobinato, trascritto e riccamente annotato da Jacques Lagrange – che ci restituisce fedelmente la parola e lo stile di Foucault: la folgorante mobilità del fraseggio, la geometrica inventività del lessico, l’incisiva persuasività dell’impianto oratorio, fatto di spezzature, di ripetizioni, di variazioni, di derive. Un testo orale che interroga criticamente e storicamente la psichiatria, aprendo un campo problematico tutt’altro che obsoleto, anche a distanza di più di trent’anni.
Ci troviamo di fronte ad una disamina straordinariamente ricca, dedicata al costituirsi di un sapere medico sulla follia e alla nascita del manicomio come luogo di custodia e di cura dei folli. Mettendo in scena il montaggio del dispositivo psichiatrico, Foucault evidenzia, tra le diverse tecniche di trattamento della follia, una particolare modalità di “curare” il delirio, così come era emersa nella “protopsichiatria” francese ed inglese del primissimo ottocento: ad esempio in Pinel, ma anche in un libro scritto dall’alienista inglese Joseph Mason Cox (Practical Observations on Insanity, London 1804) e uscito nel 1806 in una versione francese (Observations sur la démence), dalla quale Michel Foucault ha tratto le sue citazioni ed un significativo bozzetto clinico sul quale ci sembra utile soffermarci.
Un paziente quarantenne, travolto dalla sua “passione per il commercio”, sviluppa un delirio – oggi diremmo un delirio ipocondriaco – in base al quale si sente colpito da gravi malattie, e in particolar modo da quella che all’epoca veniva chiamata “gale répercutée” (PPF, 129). Invano i medici cercano di convincerlo che non è affetto da nessuna delle malattie da lui paventate. Scrive infatti Mason Cox (PPI, 125):
Nessun ragionamento fu in grado di dissuaderlo o di distrarlo da questa convinzione. Ci si decise allora a organizzare un consulto solenne riunendo al suo capezzale parecchi medici, i quali, dopo averlo esaminato per bene e aver convenuto tra loro sulla necessità di condividere le idee del malato, decisero unanimemente che la congettura era fondata e che era assolutamente necessario far riesplodere la scabbia. Gli vennero prescritte, pertanto, delle applicazioni che provocavano arrossamenti, e a causa delle quali gli uscì successivamente, su diverse parti del corpo, un gran numero di foruncoli, per guarire i quali furono sufficienti dei semplicissimi lavaggi; ma nel corso di questo trattamento i medici finsero di usare molte precauzioni, per evitare di dar luogo a nuove ricadute. Questo trattamento, prolungato per alcune settimane, risultò molto efficace. Il malato guarì completamente, e recuperò, insieme alla ragione e alla salute, tutte le facoltà dello spirito.
Il suo delirio, commenta Foucault, era stato soddisfatto. Una follia delirante sviluppatasi attorno a una falsa credenza, a un’illusione, a un errore, non può essere combattuta attraverso dimostrazioni e ragionamenti, soprattutto nella misura in cui il folle – fenomeno questo, assai frequente – si dimostra troppo spesso un soggetto refrattario all’approccio argomentativo: un soggetto, quindi, per il quale la dimostrazione razionale non produce un ritorno alla ragione ed un accesso alla verità.
La follia delirante viene allora affrontata manipolando la realtà in modo da renderla conforme al delirio. “E’ travestendo e manipolando la realtà, afferma Foucault, che la si potrà condurre in qualche modo al livello del delirio”. Ed aggiunge: “Si fa dunque delirare la realtà affinché il delirio non sia più delirio; si libera il delirio dall’inganno, in modo che non si inganni più” (PPF, 130 e PPI, 126).
Nell’ambito dell’alienistica nascente sono dunque emersi almeno due differenti approcci alla follia delirante.
Vi è stato certamente il tentativo, raccontato tra gli altri da Mason Cox, di manipolare la realtà adeguandola al delirio, cercando, tramite una procedura fondata sulla finzione, di sanare la frattura tra io e mondo. Il fattore verità – e quindi il problema della verità della follia – era collocato “al centro stesso della cura”: scaturiva cioè “dall’interno del confronto diretto tra medico e malato” (PPF, 132 e PPI, 128).
Ma vi è anche stato un diverso tentativo: quello evidenziato dal testo di Charpentier. Il bozzetto clinico da noi riportato, che Foucault non cita, rientra pienamente nell’analisi da lui proposta sul potere psichiatrico post-pineliano come potere di imposizione della realtà. Si tratta, lo si è visto, del tentativo di esibire al paziente livelli di realtà capaci di falsificare, di smentire, di delegittimare i contenuti del suo delirio: una sorta di prova di realtà, capace di imporsi nella misura in cui viene somministrata all’interno della gerarchia di potere che scandisce la vita asilare. Vengono valorizzati, in questo modo, “i diritti imprescrittibili della ragione sulla follia” (PPF, 134 e PPI, 130) – così si esprimeva Jean Pierre Falret nel 1837 – e quindi la capacità stessa dello psichiatra di diventare, come si diceva, signore del reale: “di conferire al reale quella forza stringente grazie alla quale” esso “potrà impadronirsi della follia, attraversarla per intero e farla sparire come follia” (PPF, 131 e PPI, 127). Così Foucault. Ed ancora: “Lo psichiatra è diventato colui il quale – ed è proprio questo aspetto a definirne la funzione e il compito – dovrà assicurare al reale il supplemento di potere necessario affinché possa imporsi alla follia”; ma anche colui il quale, “inversamente, dovrà togliere alla follia il potere di sottrarsi al reale. A partire dal XIX secolo, dunque, lo psichiatra è diventato un fattore di intensificazione del reale, l’agente di un sovra-potere del reale” (PPI, 127-128). Colui che sacrifica o comprime, con i mezzi più disparati, la capacità del soggetto sottoposto alle cure di costruire mondi: di delirare, di inventare mondi, di uscire dal mondo. Colui che riesce a produrre nel malato un senso di indegnità morale svalutando e psichiatrizzando le sue le capacità creative: riducendole comunque a sintomo, oltre che a motivo di colpa e di vergogna.
Motivi analoghi, anche se all’interno di una differente concezione del potere, erano già stati affrontati da Foucault nella sua Storia della follia (1961). Vediamo.
Il malato viene reso colpevole proprio perché sovrastato dalla figura del medico e dalla sua assoluta autorità sul mondo asilare: un medico capace di spiegare e di perpetuare, con la sua stessa pratica, gli antichi rituali dell’Ordine, dell’Autorità, della Punizione; un medico capace di produrre la “guarigione del folle” solo imponendogli la “ragione dell’altro”: la ragione di quei signori del reale, portatori di un ferreo e incontestabile regime di verità, ai quali l’alienista François Leuret, incline a valorizzare anche gli aspetti coercitivi del “trattamento morale”, prescriveva senza esitazione nel 1840: “Che la vostra ragione sia la loro regola di condotta”. Disciplina e cura, dentro l’asilo, sono quindi in grado di scongiurare l’affermarsi di una “verità umana della follia”. Di conseguenza, “il momento iniziale di ogni cura” dovrà necessariamente produrre “la repressione di questa inammissibile verità”, pienamente percepita nell’ “esperienza poetica” e “nel riconoscimento lirico della follia”.
Il Foucault del 1961 parla ancora di repressione. Quello del 1973 abbandona questo concetto lavorando sulla nozione di disciplina: sulla trasformazione del “rapporto di sovranità” in “potere di disciplina”. Sul passaggio da una “macrofisica della sovranità” a una “microfisica del potere disciplinare” (PPF, 28; PPI, 37).
Potremmo allora dire che nell’ordine disciplinare del manicomio non vi era spazio per l’emergere di un registro di verità della follia. Non vi era nemmeno la necessità di reprimere tale registro, poiché nell’asilo esso non trovava, di solito, adeguati ed efficaci canali di manifestazione. Conseguentemente, nella grande maison des fous non emerge quasi mai quel nesso significativo tra creatività e follia che era già stato tematizzato, a proposito della malinconia, nella cultura medica della tarda antichità e che venne massicciamente ripreso, in età rinascimentale, dai neoplatonici fiorentini e da Marsilio Ficino.
Si tratta di un nesso problematico, contraddittorio, sistematicamente eluso o negato nella quotidianità della pratica clinica; se si vuole restituire senso ed efficacia terapeutica all’orizzonte della cura, occorre oggi ripensare radicalmente questo nesso, individuando la sua presenza all’interno dei profili incerti e proteici delle malattie dell’anima. Contro ogni riproposizione dello stigma. Contro ogni mortificante opzione organicista che pretenda di ridurre la follia a patologia cerebrale, misconoscendo le sue risorse creative e il suo possibile rapporto verticale con la verità.
Nelle due ultime e folgoranti pagine della Storia della follia, Foucault aveva ben individuato proprio questo rapporto verticale – al tempo stesso ambiguo e produttivo – tra follia e verità. Un rapporto che la clinica dovrà riscoprire, pena la sua eclissi e il suo grigio decadimento a routine farmacologica, ad amministrazione burocratica del disagio. Vale forse la pena rileggere qualche passaggio significativo.
“La follia è assoluta rottura dell’opera: essa rappresenta il momento costitutivo di un’abolizione che fonda nel tempo la verità dell’opera; essa ne delinea il confine esterno, il punto di sprofondamento, il profilo contro il vuoto”.
Ed ancora: “A causa della follia che la interrompe, un’opera apre un vuoto, un tempo di silenzio, una domanda senza risposta. Provoca una lacerazione senza rimedio in cui il mondo è obbligato a interrogarsi”. Di più: “La follia in cui sprofonda l’opera è lo spazio del nostro lavoro, è l’infinita strada per venirne a capo, è la nostra vocazione sia di apostoli che di esegeti”.
E infine: “Dove non c’è opera non c’è follia; e tuttavia la follia è contemporanea dell’opera, poiché inaugura il tempo della sua verità”.
Non intravedo, in queste posizioni, nessun vagheggiamento romantico sui poteri creativi della follia. Nessun cedimento ad una retorica della follia buona, produttiva, benefica. Intravedo piuttosto un riconoscimento della contiguità tra una “lacerazione senza rimedio” – tra una lacerazione come cifra di sofferenza e di squilibrio (la follia come “assoluta rottura dell’opera”) – ed uno “sprofondamento” che interroga l’opera stessa nella sua verità più profonda e più segreta. Le pagine di Foucault ci sfidano ancor oggi a pensare e a rendere visibile questa contiguità. Con laica e paziente tenacia dovremo, poco per volta, costruire nuovi spazi del pensiero clinico che sappiano collocarsi all’altezza di questa ineludibile sfida teorica.
Ecco. Occorre precisare che una definitiva dissociazione tra follia e verità – o meglio: tra verità della follia e verità di chi la amministra – prende decisamente piede tra gli alienisti soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo XIX: quando cioè il paradigma organicista della degenerescenza riesce a egemonizzare il campo psichiatrico. Lo psichiatra diventa allora, definitivamente, “signore del reale”: forte del potere disciplinare che si dispiega entro la pratica istituzionale e che “si è imposto alla follia in nome di una verità detenuta una volta per tutte da quel potere sotto il nome di scienza medica, di psichiatria” (PPF, 132 e PPI, 128). La nosologia e l’eziologia – la nosografia psichiatrica, cioè la classificazione delle malattie mentali da un lato, l’anatomia patologica dall’altro lato – sono le due fonti della verità: le due articolazioni maggiori del discorso di verità su cui poggia la pratica psichiatrica per legittimarsi come scienza medica.
L’orizzonte della verità, espulso dalla contingenza del rapporto di forza e/o di dialogo tra medico e malato – estromesso dalle ambiguità dei giochi di verità che si instaurano tra curante e curato – si colloca allora all’esterno della relazione terapeutica: in una zona franca, sicura, univoca, laddove si configura come assetto stabile, come fondamento ineludibile del potere disciplinare e delle pratiche asilari. L’orizzonte della verità diventa così, è il caso di dirlo, regime di verità, entro il quale, come afferma Foucault, lo psichiatra “non sarà più l’ambiguo signore della realtà e della verità com’era ancora con Pinel e Mason Cox, ma sarà decisamente signore della realtà” (PPI, 127).
Il passaggio, in Foucault, sembra troppo repentino: ho l’impressione che venga messo in scena, più che un passaggio, un brusco rovesciamento di posizioni. Storicamente, lo schema evolutivo e il gioco delle parti sono stati in realtà meno semplici.
Charpentier, come si è visto, metteva in evidenza già nel 1804 una strategia terapeutica oppositiva e impositiva, mirata ad imporre, per l’appunto, la realtà al delirio. In altre parole, già nel 1804 Charpentier faceva ciò che in genere, stando a Foucault, verrà fatto in ambito asilare soltanto dopo Pinel.
Pinel, dal canto suo, nella prima edizione del Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, ou la manie (1800) rinvia più volte, è vero, ad esperimenti terapeutici, a “trattamenti morali” simili a quelli citati da Mason Cox, nei quali, cioè, la realtà è stata manipolata dai curanti per adeguarla al contenuto dei deliri. Opera, dunque, almeno agli inizi, alla stessa maniera di Mason Cox. Tuttavia, soltanto pochi anni dopo, nel 1809, come vedremo subito, adotterà anche altri atteggiamenti e altre strategie.
Il mutamento di cui parla Foucault non è stato né generalizzato, né definitivo, né irreversibile.
Lo stesso Mason Cox, ad esempio, nell’edizione londinese del 1813 delle sue Observations – dalla quale traggo le citazioni successive – continua ancora a giustificare l’utilità della “pia fraus”, della frode giusta e pietosa, degli stratagemmi di verità, come li ha definiti Foucault (PPF, 34-36): “espedienti ridicoli”, afferma l’autore inglese, ma “indispensabili”. A questo proposito, egli cita nel corso del suo libro non solo singole vicende ben definite, singoli casi clinici – alcuni dei quali riportati da Foucault – ma anche vere e proprie tipologie ricorrenti di atteggiamenti deliranti e di conseguenti espedienti solitamente adottati dal medico. Così, con il paziente convinto di avere un osso in gola che blocca la deglutizione e il passaggio di cibo, si simula un’operazione alla gola con successiva esibizione di un osso insanguinato. Allo stesso modo, se un paziente crede di avere nello stomaco o in pancia una rana, un serpente, un rospo, si mette segretamente un esemplare dell’animale in questione in un vasetto, come se fosse stato da lui espulso con il vomito o con le feci (Observations, cit., 1813, 64-65).
Esempi di questo tipo non sono nuovi nella storia della medicina antica e moderna: ne troviamo alcuni, ad esempio, nell’articolo “Mélancolie” dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, dove si insiste sulla necessità, per il “médecin prudent”, di assecondare il delirio del malato e dove si afferma con chiarezza:
Il faut qu’un médecin prudent sache s’attirer la confiance du malade, qu’il entre dans son idée, qu’il s’accomode à son délire, qu’il paroisse persuadé que les choses sont telles que le mélancolique les immagine.
[Bisogna che un medico prudente sappia conquistarsi la fiducia del malato, che entri nella sua idea, che si adegui al suo delirio, che sembri persuaso che le cose sono così come il malinconico le immagina].
(traduzione mia)
2. Complicità e imposizioni
Evitando ogni semplificazione abusiva, occorre rilevare che nella storia della medicina e della psichiatria la complicità con il sintomo e l’imposizione di realtà non sono state due tappe diverse di un unico processo evolutivo, succedutesi linearmente nel tempo: sono state invece due strategie curative utilizzate al di fuori di qualsiasi regolarità evolutiva e perciò entrambe presenti in epoche diverse oppure compresenti, a volte, in uno stesso autore, in uno stesso testo, in uno stesso periodo storico.
Nell’articolo “Mélancolie” che ho appena citato, ad esempio, vengono menzionate entrambe le strategie terapeutiche: sia le strategie simulatrici che ricorrono alla “pia fraus”, alla “ruse”, sia strategie meno accomodanti, improntate a quella che Foucault definisce imposizione di realtà, laddove cioè – come recita il testo dell’Encyclopédie – si tratta di “contrarier ouvertement” les “sentiments” dei malinconici deliranti e di “exciter en eux des passions qui leur fassent oublier le sujet de leur délire”.
A sostegno delle strategie compiacenti e simulatrici viene riportato l’esempio di Tulpius, il famoso medico e anatomista olandese Nikolaas Tulp (1593-1674), immortalato da Rembrandt: egli curò un pittore malinconico, convinto di avere le ossa del corpo molli come la cera, vietandogli di camminare per sei giorni, dopo i quali gli avrebbe permesso di farlo; finse dunque di essere “pleinement persuadé de la vérité de son accident”. Facilitato da questa finzione, il paziente “obéit exactement”: seguì scrupolosamente la prescrizione terapeutica. Trascorsi i sei giorni, “il se promena sans crainte et avec facilité”.
A sostegno delle strategie impositive e oppositive viene menzionato l’esempio di Tralliano: il medico bizantino Alessandro di Tralle (525-605), che guarì un malinconico convinto di essere senza testa “en lui mettant dessus une balle de plomb”.
Complicità e imposizione – assecondamento e contrasto – non si dispongono dunque linearmente lungo un asse temporale ed evolutivo, ma spesso coesistono oppure si scambiano le posizioni, in un intreccio non sempre lineare e coerente. Il caso di Pinel, in questa prospettiva, ci sembra davvero esemplare.
A titolo di esempio, voglio ricordare il bozzetto clinico presente nella prima edizione del suo Traité (p. 237): si tratta di un sarto malinconico e delirante ricoverato a Bicêtre, sospettato dai membri del Terrore per aver criticato la condanna a morte di Luigi XVI e dopo di allora ossessionato, “notte e giorno”, dall’ “idea di essere condannato alla ghigliottina”. Ebbene: il sorvegliante dell’asilo mette in scena, con la collaborazione di tre giovani medici, un falso processo. Alla finzione delirante, per dirla con Jean Starobinski, fa da contraltare una finzione curativa messa in atto dal gruppo dei curanti. Il malato viene assolto pienamente da una “pretesa commissione del corpo legislativo”, che gli ingiunge di rimanere altri sei mesi a Bicêtre, dove potrà esercitare la sua professione di sarto a favore degli alienati. Ciononostante il paziente ricade in uno stato di inazione e di prostrazione e da allora verrà considerato da Pinel come “incurable”.
Diversamente dalla scena tratteggiata da Mason Cox, che culmina con una sorta di trionfo terapeutico – cioè con la guarigione esibita dallo stesso paziente a tutti i suoi amici – abbiamo, qui, la confessione di uno scacco: uno di quegli “échecs”, di cui Pinel aveva già parlato, con finezza, nella prima edizione del suo trattato: scacchi, come egli diceva chiaramente, determinati dall’opacità interiore dei pazienti, dalla difficoltà a penetrare “il segreto dei loro pensieri”, dal loro “ostinato silenzio”, dal loro “umore umbratile”, dalla loro “diffidenza”, dalla loro radicata propensione a dissimulare. Nel caso del sarto malinconico lo scacco riguarda proprio il cuore del trattamento morale: un trattamento psicologico non costrittivo – almeno in questo caso – indirizzato a confermare, attraverso complicità, finzioni e simulazioni, i contenuti dell’ideazione delirante.
Non a caso, nella seconda edizione del suo trattato (1809) Pinel pensò bene di omettere questa scena, aggiungendo in compenso un’intera sezione dedicata alla “police intérieure des asiles”: regole di comportamento, provvedimenti relativi all’organizzazione disciplinare dell’asilo, “ergoterapia”, obbligo al lavoro, eccetera. Una panoplia di misure, insomma, finalizzate a riavvicinare i pazienti alle evidenze del senso comune e alle abitudini di una quotidianità perduta.
Tra il 1800 e il 1809 si verifica dunque una metamorfosi della postura clinica, sullo sfondo di una minor fiducia nella capacità di guarire, di penetrare l’interiorità dei pazienti, di accedere al senso e alla struttura del loro delirio. Ad una strategia terapeutica, che non verrà mai del tutto abbandonata, incline a manipolare la realtà affinché essa confermi la verità del delirio – qualcosa di simile, forse, alla prescrizione del sintomo o allo spostamento del sintomo, praticati in tempi recenti da Paul Watzlawick – viene ad affiancarsi una strategia capace di imporre la realtà alla follia, togliendo al delirio il potere di sottrarsi al reale. Il “trattamento morale”, in questa prospettiva, assume molto spesso le caratteristiche di una terapia concepita come addestramento funzionale al riconoscimento della realtà e della verità: realtà e verità delle persone, delle situazioni, degli oggetti. Realtà e verità alle quali l’alienista può ricondurre i suoi pazienti solo nella misura in cui sarà in grado di utilizzare due registri conoscitivi e operativi distinti ma necessariamente complementari: da un lato le risorse della pratica medica e farmacologica, dall’altro lato “l’amour du vrai et la supériorité des lumières”; da un lato “les connaissances de la médecine”, dall’altro lato “celles de l’idéologie” (si veda, in questa direzione, l’articolo “Aliénation” scritto da Pinel nel 1812 per il celebre Dictionnaire des sciences médicales edito a Parigi da Panckoucke).
Cerchiamo di fare il punto. Nei primi vent’anni del XIX secolo strategie terapeutiche fondate sull’imposizione e strategie terapeutiche fondate sulla complicità e sulla simulazione si alternano e spesso si affiancano. Il Pinel che diffida delle strategie compiacenti fondate sulla simulazione è poi lo stesso che nel 1816 – in un articolo consacrato alla “Mélancolie” e pubblicato nell’Encyclopédie méthodique – cita la “ruse”, lo “stratagemma” terapeutico già menzionato nell’Encyclopédie e nel testo di Mason Cox a proposito di una particolare e frequente tipologia di pazienti psichiatrici: i malinconici deliranti persuasi di avere nello stomaco serpenti, rane o altri animali. Nella stessa pagina – vale la pena ricordarlo – Pinel cita anche, quasi alla lettera, il passo in cui l’autore dell’Encyclopédie faceva riferimento al paziente malinconico curato dal dottor Tulp.
Da un lato, dunque, si è cercato di assecondare il sintomo; tale scelta era già presente nella medicina pre-psichiatrica ed è stata poi ripresa sia nell’ambito della protopsichiatria – soprattutto dal primo Pinel, dal giovane Esquirol, da Mason Cox – sia in contesti a noi più vicini: penso a Paul Watzlawick, oppure, per uscire dall’ambito psicoterapico, a Carlos Castaneda e agli insegnamenti del suo maestro, lo stregone Don Juan.
Dall’altro lato, soprattutto nella psichiatria clinica post-pineliana del XIX secolo, si opterà per una soppressione del sintomo: per una sorta di lotta al sintomo (come la definì lo stesso Paul Watzlawick), gestita attivamente dal terapeuta all’interno del suo reticolato disciplinare e con il supporto del suo “sapere”.
Interessati, come siamo, alla prospettiva di un impegno in medias res e di una riflessione di taglio genealogico attorno ai metodi della psichiatria clinica, vorremmo comprendere criticamente e senza forzature ideologiche – anche utilizzando Le pouvoir psychiatrique – la fisionomia delle componenti terapeutico-relazionali che caratterizzarono la prima alienistica. La posta in gioco di questa comprensione riguarda direttamente la qualità e le prospettive del nostro impegno epistemologico nell’ambito della psichiatria clinica. Sarà allora opportuno cominciare a porre almeno due questioni preliminari, in forma interrogativa:
1. Quali sono le caratteristiche della prima fase del cosiddetto “trattamento morale” descritte da autori come Pinel, come Mason Cox, come Haslam, come il giovane Esquirol, all’incirca nel primo decennio della psichiatria nascente, tra il 1800 (l’anno di pubblicazione del Traité pineliano) e il 1809 (l’anno di pubblicazione della seconda edizione del Traité)? Momento eroico, sopravvalutato dalla critica ad orientamento neo-liberale e forse sottovalutato da Michel Foucault. Si tratta insomma di capire profondamente il senso che ha avuto, nella fase di avvio del trattamento morale, l’ambiguità del gioco di verità tra paziente e curante e il rinvio, facilmente ritrovabile nei testi (si pensi, se non altro, al trattato pineliano), al mondo interno del malato, alla possibilità di modificarlo, all’ottimismo terapeutico implicito nella stessa ammissione di tale possibilità.
2. Come si collegano tra di loro, nello spazio asilare, giochi di verità e tattiche di simulazione? In che misura le dinamiche della simulazione e della dissimulazione – presenti non solo nell’alienistica delle origini, ma anche in tutta la psichiatria clinica europea, almeno da Pinel a Freud – hanno sempre implicato nozioni (e pratiche relative) riguardanti il mondo interno sia del paziente che del terapeuta?
3. “Apparato di forza” e system of soothing
Mi soffermo per ora sui problemi aperti dalla prima questione. Voglio cominciare con la citazione di un passo della già ricordata thèse di dottorato di Esquirol (Delle passioni, edizione italiana citata, p. 141). Afferma l’autore, a proposito dei folli:
I folli (…) più o meno, ragionano tutti; ci appaiono deliranti solo per la nostra difficoltà a conoscere l’idea prima alla quale si riallacciano tutti i loro pensieri, tutti i loro ragionamenti. Se fosse facile mettersi in armonia con questa idea-madre, non ho dubbio che si potrebbe guarire un più gran numero di alienati.
A partire dall’interpretazione della thèse esquiroliana e soprattutto di passi analoghi a questo, si è sviluppata soprattutto in Francia – penso all’importante monografia di Marcel Gauchet e di Gladis Swain – una lettura parziale, anche se ricca e approfondita, della prima alienistica e del “trattamento morale”, considerato come antecedente storico della psicoterapia.
Si è sottovalutato il peso della cornice asilare, delle sue discipline, delle sue curvature dispotico-repressive: il peso di quello che lo stesso Esquirol, nel testo appena citato, chiama l’ “appareil de force” (l’apparato di forza), pilotato dal medico e garantito, entro il perimetro manicomiale, dalla presenza di una capillare e precisa “distribuzione tattica del potere” (così la definisce Foucault), cioè da una compartimentazione delle funzioni terapeutiche e disciplinari, di cura e di custodia, che implica il coordinamento tra i vari personaggi dell’asilo, organizzati entro una ferrea struttura gerarchica, sulla quale torneremo più avanti: il “médecin en chef”, i medici ausiliari, gli infermieri, i sorveglianti (“les surveillants”), i servi o guardiani (“servants”, “gardiens”). Senza questa distribuzione tattica del potere e senza la presenza operativa di un apparato di forza, verrebbero meno l’autorità del medico e l’efficacia delle cure. Autorità medica ed efficacia terapeutica, per realizzarsi, hanno bisogno di poggiare su una ben collaudata capacità di reprimere, di controllare, di sedare, anche attraverso l’uso di efficaci metodi di contenzione (camicia di forza, manicotti, letti di contenzione, docce calde e fredde, sedie rotatorie, eccetera).
Pinel ha tolto le catene ai folli, è vero, ma non per liberarli, come hanno preteso molte agiografie ottocentesche e qualche ideologica celebrazione novecentesca. Il gesto liberatore – che per le discipline psichiatriche ha assunto il ruolo di un vero e proprio mito di fondazione – era direttamente funzionale all’immissione dei folli entro le maglie di un nuovo ed efficace reticolato disciplinare: efficace, nell’intenzione dell’alienista, sul terreno del controllo ma anche su quello, derivato e congiunto, dello sforzo terapeutico. Pinel ha dunque tolto le catene ai folli per poi sottometterli ad un nuovo regime di potere: per trasformarli in malati obbedienti e curabili sia attraverso il “traitement moral”, sia attraverso un uso tattico della repressione e una sapiente regolazione delle condotte manipolative.
Nell’asilo nascente, empatia e contenimento – caratteri distintivi, anche se parziali e limitati, della relazione di cura – si esprimono in ogni caso solo a partire da un campo disciplinare ben strutturato e da un apparato di forza sempre presente e utilizzabile. Foucault lo ha spesso scritto, detto e ribadito: entro il perimetro dell’asilo, è la vigenza del potere disciplinare – che include sempre la dimensione della “forza” e della repressione – ciò che rende possibile l’elaborazione psichiatrica di un discorso di verità. L’asilo, l’ospedale, è dunque “machine à guérir” (PPF, 103) solo nella misura in cui funziona come sistema disciplinare.
Di conseguenza, il discorso di verità, o l’emergenza della verità come operazione psichiatrica, è possibile solo a partire dal funzionamento e dall’efficacia del sistema disciplinare e delle sue tecniche di controllo sulla popolazione internata.
Sottovalutare questo nesso tra cura e disciplina – tra dialogo e coercizione, tra terapia e controllo, tra contenimento e contenzione – significa fornire oggi, agli operatori della salute mentale, una sorta di cattiva coscienza: significa supportare, con il conforto di un’antica e radicata tradizione – forzosamente mitizzata e ideologizzata – la rimozione delle valenze di potere che ogni presa in carico di un paziente necessariamente e inevitabilmente implica. Il lavoro di Foucault ci serve ad evitare questa pericolosa rimozione: a non dimenticare mai i nessi che collegano, entro l’impresa psichiatrica – entro qualsiasi impresa terapeutica, educativa, riabilitativa – verità e potere.
L’analisi di Foucault va tuttavia integrata e approfondita proprio in relazione agli aspetti dialogico-curativi dell’alienistica nascente e, più in generale, di tutta la psichiatria clinica.
Dicevamo di voler affrontare anzitutto il primo dei due interrogativi poc’anzi formulati, a partire da una citazione del giovane Esquirol, laddove si perora la necessità di mettersi in armonia (“se mettre en harmonie”) con l’idea-madre da cui dipende lo sviluppo del delirio.
Intravediamo qui – in questo testo “minore”, quasi dimenticato – le prime e ancora incerte tematizzazioni di una vera e propria empatia clinica (un concetto, lo si sa, che appartiene oggi alle formulazioni più sofisticate della psicopatologia).
Paradossalmente, l’atteggiamento empatico connesso alla relazione di cura affonda le sue radici storiche nel sistema disciplinare dell’asilo: in particolar modo dell’asilo privato, cioè della “casa di cura borghese, a pagamento” (PPI, 115). Foucault cita, al riguardo, le case di cura private di Esprit Blanche e di Brierre de Boismont. Non menziona invece la maison de santé diretta dal giovane Esquirol: fucina, come si è già detto, della sua thèse. Esquirol stesso, del resto, durante la fase della sua piena maturità scientifica, apre nel 1827 una casa di cura privata ad Ivry, assieme a suo nipote, l’alienista Jules Mitivié. Dopo la morte di Esquirol, nel 1840, Mitivié si fa aiutare, per gestire questa clinica, da due allievi dello zio: i noti alienisti Jacques Moreau de Tours e Jules Baillarger, che diventeranno poi i proprietari della casa di cura.
“Scopo” di queste maisons de santé a conduzione privata “è, in fondo, quello di trarre profitto, e il massimo del profitto, da quella forma di emarginazione in cui consiste la disciplina psichiatrica” (PPI, 113). Queste case di cura erano “parallele agli ospedali e agli istituti pubblici ma al contempo molto diverse da questi”: qui si cominciano a ricavare i profitti ricavati dalle anomalie, “i profitti desunti dalle diverse forme di illegalità, i profitti tratti dalle irregolarità” (PPI, 111). Ma qui si afferma anche un processo di “familizzazione dell’ambiente terapeutico” (PPI, 115), funzionale alle richieste provenienti dalle famiglie agiate dei ricoverati; esse pretendevano dall’alienista una cura capace di riportare nell’alveo della famiglia i congiunti che erano stati internati proprio a causa della loro mancata o mal riuscita integrazione nella logica degli affetti domestici: congiunti affidati alla casa di cura da famiglie disciplinarizzate, che svolgono cioè “il ruolo di istanza che decide del normale e dell’anormale, del regolare e dell’irregolare” (PPI, 116-117). In tale contesto “guarigione” diventava sinonimo di “riattivazione del sentimento famigliare” (PPI, 114) in soggetti che lo avevano palesemente smarrito.
Un duplice movimento deve dunque caratterizzare questa ricercata sinergia tra famiglia e asilo: da un lato una familizzazione dell’ambiente terapeutico, che innesta il modello della famiglia sul sistema disciplinare della “maison des fous”; dall’altro lato un disciplinamento della famiglia, che innesta le tecniche disciplinari sugli assetti della sovranità familiare. La famiglia disciplinarizzata sarà dunque il primo luogo di individuazione del folle. “Designando il folle”, essa lo affiderà a una particolare casa di cura, capace di “fabbricare degli individui rifamilizzati” (PPI, 114).
Proprio all’interno di questa strategia, emerge una postura terapeutica che abbiamo definito, anche sulla scorta della thèse esquiroliana, empatica. In maniera più pertinente – più aderente ai testi e meno anacronistica – vorrei definirla come postura centrata sulla consonanza psicologica. Sull’affetto reciproco che lega il paziente ricoverato e i membri della sua nuova famiglia asilare. In particolar modo, sul legame affettivo tra il paziente e la coppia “genitoriale” formata dal direttore della casa di cura e da sua moglie. E’ stato il caso dei coniugi Blanche, durante l’età della Restaurazione. E’ stato il caso della maison del faubourg Saint-Antoine diretta dal famoso alienista Alexandre Brierre de Boismont e da sua moglie: casa di cura privata e al tempo stesso alloggio di Brierre e della sua famiglia.
Foucault cita, a titolo d’esempio, un passo della lettera scritta nel 1847 da un ex ricoverato alla signora Brierre de Boismont. Vale la pena rileggerlo (PPI, 114), per motivi che vedremo subito:
Lontano da voi, signora, ho spesso interrogato il ricordo, così profondamente scolpito nel mio cuore, per godere ancora della calma piena d’affetto che voi comunicate a coloro che hanno avuto la fortuna di essere accolti nella vostra intimità. Ritornerò spesso, col pensiero, alla vostra famiglia, così unita in tutti i suoi membri, così affettuosa in ciascuno di essi, e in particolare alla primogenita, tanto graziosa quanto intelligente. Se farò ritorno, come spero, dai miei, avrete presto una mia prima visita, poiché si tratta di un debito del cuore.
Commento di Foucault: “Questa lettera mi sembra molto interessante, perché mostra che il criterio, la forma stessa della guarigione, consiste nell’attivazione di sentimenti di tipo familiare nel senso canonico del termine”.
La lettera, in realtà, mette in rilievo l’intensità e l’importanza fondamentale di un clima affettivo che investe entrambi i termini della relazione: da un lato la signora (con la sua famiglia), dall’altro lato i suoi pazienti-ospiti. Parlare perciò soltanto di “sentiments de type canoniquement familial” e di “reconnaissance à l’egard du père et de la mère” (PPF, 115) per definire questo scenario ci sembra un modo di impoverire la sua pregnanza affettiva, sottovalutando l’intensità di quell’espressione dolce e vibrante che esce spontaneamente dalla penna dell’ex ricoverato: mi riferisco a quella calma piena d’affetto, attribuita a Madame Brierre de Boismont, che fa pensare a qualcosa di più di una famiglia modello, di una “famiglia ideale”, capace, per dirla con Foucault, di esprimere una “funzione ortopedica”, normalizzatrice e terapeutica.
La finalità strategica di queste maisons de santé a conduzione familiare è senza dubbio quella di espletare una funzione ortopedica. Ma tale funzione si realizza proprio nella misura in cui il paziente-ospite viene immerso, entro l’ “intimità della famiglia” (UT, p.47 [con UT, d’ora in poi, cito (e traduco) dallo scritto di Brierre “De l’utilité de la vie de famille”, del 1866, uscito nella importante rivista “Annales Médico-psychologiques”]) in un presente ricco, vario, pregnante: un nuovo clima relazionale, insomma, ordinato e disciplinato ma al tempo non privo di dolcezza e di serenità. Se è vero che dolcezza e affettività poggiano e si sviluppano sopra un’intelaiatura di carattere disciplinare – “l’ordre dont ils subissent la loi” (UT, 50): e cioè un ordine che impone le proprie leggi ai pazienti – è altresì vero che i pazienti inseriti in queste case di cura private (che coincidono, nel caso di Brierre, con i “logements” dell’alienista e della sua famiglia) accettano il regime disciplinare proprio perché attratti dalla possibilità di godere i benefici di questa “vita intima e familiare” (UT, 47). Benefici affettivi, sociali e terapeutici: “le carezze dei nostri bambini”, “le consolazioni”, “l’interesse”, le “prove d’affetto” della Signora, la partecipazione alla vita sociale della famiglia, “gli sforzi del medico, che attinge alla conoscenza del carattere i mezzi morali da utilizzare” (UT, 45). Brierre, anche attraverso la presentazione di alcuni casi, intende dimostrare le benefica “influenza della vita di famiglia negli asili privati” (UT, 41). La vita di famiglia, dunque, come risorsa terapeutica – sulla scia del “trattamento morale” di Pinel ed Esquirol – e come strumento di ricostruzione dell’affettività e della socialità. La vita di famiglia – con la “varietà di personaggi, di conversazioni, di atti, di oggetti” (UT, 42) che la animano – ha il potere di distrarre “i monomani, assorbiti nella loro idea fissa” (UT, ibidem), riportandoli alla realtà e al mondo. Ecco ciò che produce, “alla lunga, un’impressione” salutare “su queste menti malate”, al punto che “il ghiaccio, poco per volta, si scioglie”: “l’azione incessante del ragionamento benevolo, i consigli, le esortazioni, le consolazioni, il dono così sublime di piangere con coloro che soffrono, i segni di interesse e di simpatia generosamente mostrati, ogni giorno, ai feriti della società da parte di estranei animati dall’ardente desiderio di soccorrerli” (UT, 48, sottolineatura mia).
Insisto su tali declinazioni emozionali, particolarmente evidenti in questo testo, poiché ritengo che il trattamento morale della prima alienistica, tra Pinel e Brierre, non possa essere letto come mera epifania dell’ordine coercitivo e disciplinare. E’ un ordine che in realtà si interseca, in modi complessi e contraddittori, con l’anima dialogico-terapeutica della psichiatria nascente.
La disciplina, dunque, la forza e la cura: occorre sempre valutare il particolare tipo di interazione che lega tra di loro queste dimensioni, senza cedere a tentazioni semplificatrici e riduzioniste.
L’enfasi sul potere disciplinare (è l’alienistica ottocentesca letta da Michel Foucault), l’enfasi sui meccanismi coercitivi e repressivi prodotti dall’istituzione segregante (è il Pinel letto in chiave antipsichiatrica), l’enfasi sul “trattamento morale” come cura psicologica (è la protopsichiatria letta da Marcel Gauchet e Gladis Swain): sono tre diverse rappresentazioni dello stesso fenomeno; tre declinazioni del fare storia a partire dalle congiunture, dalle sollecitazioni, dalle poste in gioco del presente. Un fare storia che necessariamente utilizza, come strumento conoscitivo, l’anacronismo. Ma un’epistemologia dell’anacronismo, già perorata con molta intelligenza da Georges Didi-Huberman, dovrebbe comunque spingerci ad un atteggiamento prudente e disincantato. In altre parole, se un particolare tipo di anacronismo è inevitabilmente connesso al nostro modo di fare storia, non per questo lo si deve assumere passivamente come orizzonte esclusivo e come necessità inconfutabile.
Un uso relativista, storico e non dogmatico dell’anacronismo implica, qui, una lucida percezione dei variegati profili che individuano il nostro presente: una chiara consapevolezza delle sue differenti spinte progettuali, delle sue diverse proiezioni intenzionali, dei molteplici dispositivi che possono includerlo.
Ritornando al tema del trattamento morale e della segregazione asilare, occorre restituire alle tre opzioni storiografiche prima menzionate un autentico respiro relativista: il solo capace di mettere a fuoco la loro eventuale inerenza a fenomeni che in tempi e spazi differenti – o addirittura nell’ambito della stessa congiuntura spazio-temporale – si sono rivelati complementari o quanto meno compresenti e interagenti.
Occorre sviluppare, di conseguenza, fuori da ogni tentazione apologetica, un approccio critico antiriduzionista alla genealogia, all’antipsichiatria e all’ottica psicoterapica. Si tratta insomma di comprendere, per ognuna di queste tre prospettive, la modalità di funzionamento dello specifico terreno che funziona come vettore e come orizzonte della riduzione: l’istanza disciplinare, l’istanza repressiva, l’istanza psicologica. Tre istanze che scandiscono, con peso e modalità variabili, la vita quotidiana dell’asilo ottocentesco.
L’insistenza sulla prima e sulla seconda istanza veicola un riduzionismo sociologico e una difficoltà a cogliere i soggetti nella loro specificità personale; l’insistenza sulla terza istanza, correlata a un’opzione politica di stampo neoliberale, veicola un riduzionismo psicologico e una certa difficoltà a cogliere i soggetti nella loro specificità socio-economica, culturale e antropologica.
Un uso vigile dell’anacronismo, unito ad una consapevolezza del presente che ci attraversa e dei dispositivi che lo includono: solo così riusciremo forse a restituire a questi testi dell’alienistica ottocentesca la loro pregnanza prospettica. Il che significa collocare la comprensione del trattamento morale e della segregazione asilare all’interno di un’analisi più generale, capace di restituirci la complessa relazione, variabile nel tempo e nello spazio, tra libertà e dominazione: più in particolare, tra cura e controllo, tra terapia e disciplina.
Il nostro presente è molto spesso attraversato, in svariati settori della vita individuale e collettiva, da questa problematica relazione, troppo spesso rimossa o misconosciuta. E’ qui, all’altezza di questa temperatura critica, che il lavoro storico-genealogico diventa sfida politica e scommessa esistenziale.
Visto all’interno di questa prospettiva, l’asilo si presenta come un micropotere – una sorta di singolare ossimoro – che mette assieme, in un connubio che può sembrare paradossale e contraddittorio, l’assoggettamento e la presa in carico, la violenza e l’ascolto, il controllo e la persuasione. Si verifica nell’asilo ciò che Alexis de Tocqueville intravedeva, su larga scala, all’interno delle nascenti società democratiche (soprattutto la società americana): un’originale coabitazione tra sicurezza e libertà, tra dispotismo connesso alle misure di sicurezza e libertà connessa ai nuovi modi di organizzare, anche sul piano giuridico, gli assetti della società civile.
Ma torniamo alla protopsichiatria asilare e alla presenza, al suo interno, di un approccio “empatico” al paziente, sul quale vale forse la pena soffermarsi valorizzando le indicazioni fornite da Brierre nel suo già citato articolo dedicato all’uso terapeutico della “vie de famille”.
“Volete restituire alla società malati che la necessità ha costretto a isolare? Mostrate loro gli aspetti positivi di questa società, assolvendo, accanto a loro, le funzioni di consolatore, in una parola di amico, medico dell’anima e del corpo” (UT, 50-51, sottolineatura mia).
Poco prima, per evidenziare la necessaria tonalità affettiva di questa opzione terapeutica, Brierre aveva dato grande risalto alla funzione positiva della già citata “rispettabile Signora Blanche” e di sua moglie: “la compagna devota” che collaborava con lui alla direzione della clinica privata a conduzione familiare ubicata nel faubourg Saint-Antoine.
Grazie a questa importante presenza femminile, l’alienista poteva contare sull’apporto di un solido sostegno osservativo: di “quell’osservazione di tutti i giorni, di tutte le ore, di tutti i minuti, per così dire, riferita con perfetta esattezza di memoria” dalla sua “compagna devota” che gli era “di così grande aiuto” (UT, 47). La parola italiana aiuto corrisponde, qui, al termine francese “secours”, che ci restituisce più puntualmente l’idea di un sostegno necessario, di un contributo indispensabile. Un contributo finora misconosciuto dagli storici, che sembra rappresentare, secondo Laure Murat, “un elemento eterogeneo all’interno del dispositivo maschile abituale (medici, infermieri, guardiani), che permette di introdurre una forma inattesa di alterità, fatta di flessibilità e di dolcezza”.
Qualità specificamente femminili, proprie della “buona sposa”, concorrono in effetti, secondo Brierre, ad una conduzione ottimale della maison: “un’estrema pazienza, uno spirito di giustizia e di fermezza, una grande costanza dell’umore, una perfetta moderazione dei sentimenti, un fondo inesauribile di bontà e una religione illuminata” (UT, 51). Ma soprattutto, più di ogni altra qualità, un “istinto materno soddisfatto. La madre di famiglia ha nel suo cuore corde che possono vibrare solo in lei; pronta a trasalire di fronte ai dolori che conosce così bene, le sue consolazioni hanno un’intonazione che nessun altro può imitare” (UT, 52).
Di conseguenza Brierre raccomanda agli psichiatri di scegliere con cura la donna da sposare, poiché essa potrà “rendere immensi servigi allo stabilimento” (UT, 49), soprattutto se diventerà madre. Egli mette dunque in scena la donna – in quanto madre e in quanto sposa del medico – come soggetto particolarmente adatto alla cura, facendoci anche intendere che questa figura poteva ricevere attenzione e apprezzamento nel contesto familiare e professionale degli alienisti. Non a caso cita l’opinione che la “moglie di un direttore d’asilo”, parlando con lui dell’argomento, gli aveva comunicato personalmente: “Sento che se la sposa del medico aggiunto che ci viene inviato non è madre, una barriera invalicabile ci separerà” (UT,52).
Nell’ambito della clinica privata della prima metà dell’ottocento, emerge insomma un fenomeno originale: si cerca di realizzare, anche con l’apporto della presenza femminile, un sistema di ammorbidimento – di lenimento, di addolcimento – dell’inevitabile durezza connessa alla segregazione asilare.
Edgar Allan Poe registra con esattezza l’originalità del fenomeno nel racconto The System of Dr. Tarr and Prof. Fether (1845), dove la gestione asilare sperimentata da Blanche e da Brierre viene definita, con straordinaria precisione, un system of soothing: non un “sistema dolce” – come propone la versione italiana di Giorgio Manganelli – e neppure un “système de la douceur”, come recita, nel 1865, la traduzione francese di Charles Baudelaire. Per rimanere fedeli al testo di Poe, attento alla realtà dei manicomi privati francesi, occorre un termine italiano che ci restituisca l’idea dinamica di un “sistema” capace di attenuare, di lenire, di ammorbidire, per l’appunto, una realtà oggettivamente dura e difficile. Non dunque un sistema di per sé stesso dolce: semmai un sistema di addolcimento, che si misura con l’esistenza di una durezza da mitigare – quella connessa alle dinamiche del controllo e della segregazione asilare – all’interno di un contesto in cui era necessario, in certi casi, esercitare una moderata repressione. Come scriverà Brierre, anche nell’asilo privato ci sono “eccezioni”: malati difficilmente curabili, resistenti, “indocili”, i quali, “a causa della natura delle loro idee devono essere sottomessi all’intimidazione e assoggettati alla regola del lavoro” (UT, 48, sottolineatura mia). Ma si tratta comunque di eccezioni, non della regola generale.
4. Blanche contro Leuret. “Intimidazioni” e “revulsioni morali”
Già nel suo testo del 1839 (Du danger des rigueurs corporelles dans le traitement de la folie, pp. 1-52), Esprit Blanche avvia una forte polemica proprio attorno a questo delicato distinguo. Contesta infatti a Leuret un uso continuo e sistematico dell’intimidazione, della “révulsion morale”. Appoggiandosi a Pinel e a Esquirol, Blanche sostiene che il loro trattamento morale prevedeva soltanto un ricorso limitato, prudente, discontinuo e non generalizzato alla repressione. Per imporre il suo punto di vista, prima riporta alcune “sages paroles” del venerato Pinel, che spronava gli alienisti a realizzare “un heureux mélange d’une fermeté impostante et d’un coeur compatissant et sensibile” (p. 17); poi, subito dopo (p.19), in opposizione a Leuret, dà risalto a un passaggio significativo del celebre alienista di Tolosa, largamente citato sia in questo testo del 1839 sia in quello successivo, del 1840 (De l’état actuel du traitement de la folie en France): “Des punitions arbitraires – secondo Esquirol -, la réclusion prolongée, les coups, les propos grossiers, les menaces irritent, loin de calmer. Si la répression est nécessaire, exercez-la sans emportement, sans brutalité, sinon le maniaque ne verra que colère dans votre conduite”.
In definitiva, Leuret e i “prôneurs des rigueurs corporelles” tradiscono il lascito dei padri fondatori. Di conseguenza, dato che si discostano vistosamente dal loro insegnamento, “ils invoquent à tort l’exemple et le témoignage” di Esquirol (p.18). Radicale, dunque, per Blanche, la distanza tra Leuret e gli insegnamenti del medico di Tolosa.
Questo scritto del 1839, presentato all’Académie Royale de Médecine, era stato corredato da cauzioni ufficiali e autorevoli: quella del dottor Étienne Pariset, “rapporteur”, e quella di Esquirol, che compare come firmatario. Nel suo Rapport, che segue immediatamente lo scritto del 1839 (pp. 53-62), Pariset loda e approva le posizioni di Blanche. Condanna i metodi improntati a “la rigueur” e a “l’intimidation”, usati per contrastare i deliri e per estirpare le “false idee” degli alienati. E aggiunge: “adottare” nei loro confronti “un sistema di condotta in cui domina il rigore, significa andare incontro alla disillusione più crudele. Mal compreso dai vostri collaboratori e dai vostri allievi, questo rigore degenera ben presto in barbarie” (p. 62). Ma la condanna viene mitigata da un atteggiamento mediatorio: secondo l’autore del Rapport, Leuret intendeva esporre dei fatti, senza alcuna pretesa di fondare una dottrina. Concepiva perciò “les rigueurs” e “l’intimidation” non come sistemi dominanti, generalizzabili, ma solo come percorsi necessari nei casi più difficili. Nelle patologie più gravi. Affermazioni contraddette da Blanche già nel testo del 1839, dove si afferma chiaramente che “les rigueurs corporelles” – definite perentoriamente un “metodo barbaro” – non rappresentano un “mezzo ausiliario” ma la base stessa del trattamento: “la base du traitement de la folie”. Dove l’uso intimidatorio della doccia viene definito, senza mezzi termini, una “tortura fisica”.
L’atteggiamento indulgente e compromissorio di Étienne Pariset è comprensibile. Blanche era certamente molto conosciuto a Parigi, e non solo nell’ambiente medico, dato che la sua clinica privata era diventata un luogo di ricovero per scrittori, artisti e musicisti della capitale. Era tuttavia marginale rispetto all’establishment della psichiatria pubblica, al quale Leuret apparteneva invece organicamente ancor prima che venissero pubblicati i suoi due saggi più importanti: i Fragments psychologiques sur la folie (1834) e il più famoso Du traitement moral de la folie (1840), bersaglio privilegiato delle invettive di Blanche.
Infatti, già nel primo numero (1829) delle “Annales d’Hygiène publique et de médecine légale” (AHP) – un’importante rivista fortemente perorata da Esquirol – troviamo il trentaduenne François Leuret come redattore-capo (“rédacteur gérant”) e come membro del comitato direttivo, accanto a figure di grande peso tra cui vale la pena menzionare lo stesso Esquirol (indicato come Ispettore generale dell’Università e medico-direttore della maison royale di Charenton), Marc (noto alienista, dedito soprattutto alla medicina legale della follia), Orfila, Parent-Duchâtelet e Villermé.
Nel Prospectus non firmato del numero inaugurale è già evidente l’orizzonte tematico privilegiato delle AHP: i rapporti tra medicina e “organizzazione sociale”. Applicate ai “bisogni della società”, le scienze mediche hanno il compito di lavorare al “mantenimento della salute pubblica”. Ed è proprio la “conservazione della salute pubblica” – a cui Charles Marc dedica un denso profilo storico nell’Introduction – la nuova cornice di riferimento (teorica, pratica, istituzionale) del sapere psichiatrico: un sapere sempre intrecciato agli sviluppi della medicina legale e dell’igiene pubblica e quindi tutt’altro che secondario, già nei primi decenni della sua storia, rispetto alla gestione complessiva della santé publique.
Qualche annotazione attorno ai due ultimi nomi del comitato direttivo prima menzionato ci aiuta a comprendere pienamente il senso della nuova iniziativa editoriale. Louis Villermé (1782-1863) è medico e membro di primo piano della “Società reale di Parigi per il miglioramento delle Prigioni”, fondata nel 1819. L’anno successivo pubblica un’opera importante sulle prigioni, nella quale la situazione carceraria, come esplicita il sottotitolo, viene studiata, con il prezioso supporto di indagini sul terreno, in rapporto all’Igiene, alla Morale e all’Economia Politica.
Nel primo numero delle AHP Villermé riprende il tema del suo libro con un lungo intervento, nel quale analizza e denuncia la “mauvaise tenue des prisons” come fattore che determina le malattie e l’elevato tasso di mortalità dei detenuti. Molto evidente, sia nell’intervento che nel libro, l’ispirazione filantropica e riformatrice. Lo studioso di medicina sociale e di igiene pubblica sottopone al ceto politico strumenti utili al varo di nuovi provvedimenti legislativi: atteggiamento presente sia nei lavori sulle prigioni sia negli interventi di capitale importanza dedicati alla questione sociale, come ad esempio il famoso Tableau del 1840 sulla condizione operaia.
Qui l’autore rivendica orgogliosamente la scelta metodologica già collaudata nel suo studio sulle prigioni: indagini sul terreno, contatti diretti con gli operai, seguìti in tutto l’arco della loro giornata, dalla fabbrica fino all’abitazione. “J’ai suivi l’ouvrier depuis son atelier jusqu’à sa demeure. J’y suis entré avec lui, et je l’ai étudié au sein de sa famille; j’ai assisté à ses repas.J’ai fait plus: je l’avais vu dans ses travaux et dans son ménage, j’ai voulu le voire dans ses plaisirs, l’observer dans les lieux de ses réunions. Là, écoutant ses conversations, m’y melant parfois, j’ai été, à son insu, le confident de ses joies et de ses plaintes, de ses regrets et de ses expérances, le temoin de ses vices et de ses vertus” (Intr., VI). Indagini a tutto campo, quindi, che dovevano permettere all’autore di “constater, aussi exactement qu’il est possible, l’état physique et moral des classes ouvrières” (Intr., V, sottolineatura dell’autore). Magistrati, medici, industriali, operai: tutti, come viene sottolineato con gratitudine, si sono premurati di collaborare a questa delicata inchiesta, dove bisognava “interroger la misère sans l’humilier, observer l’inconduite sans l’irriter” (Intr., VI). Villermé si presenta come fautore di una posizione equilibrata e non ideologica, lontana sia dalla sottovalutazione sia dalla sopravvalutazione della nocività del lavoro industriale. Davvero straordinaria la risonanza del Tableau negli ambienti intellettuali e nel mondo politico:
Egli contesta e cita più volte, infatti, la famosa opera del medico ed economista inglese Andrew Ure – The Philosophy of manufactures –, apologeta del modo capitalistico di produzione, antagonista dell’associazionismo operaio, accanito avversario di tutte le posizioni che mettevano in discussione il sistema industriale e i suoi effetti sulla salute della popolazione. Esaltare il ruolo progressivo della macchina, significava, per Ure – per questo Pindaro inglese del sistema manifatturiero, come lo definisce Marx nel 1845 – valorizzare un efficace antidoto alla “sedizione” degli operai e alla temibile trama delle loro rivendicazioni. E il sapere medico, secondo Ure, forniva dati molto rassicuranti che dimostravano la legittimità morale e politica di questa esaltazione. Villermé si contrappone a Ure appoggiandosi direttamente a fonti mediche e statistiche inglesi: dall’opera ufficiale sulla popolazione della Gran Bretagna, promossa nel 1833 dalla Camera dei Comuni (II, 265), a specifici rapporti medici, come quelli del 1832 dedicati al calore sviluppato dalle stufe dell’industria cotoniera e ai suoi effetti sulla salute (II, 215-223). “C’est assez, je crois – questa la drastica conclusione –, pour montrer que les assertions de M. Ure n’ont aucun fondement” (II, 274).
Ritroviamo un’ispirazione non molto diversa da quella di Villermé nei lavori di Alexandre Parent-Duchâtelet (1790-1836), che nel primo numero delle AHP pubblica, assieme a Jean-Pierre D’Arcet (chimico ed esperto di igiene pubblica), un intervento in cui dimostra, in contrasto con una posizione ben radicata nella letteratura medica, che il tabacco non determina particolari patologie negli operai che lo lavorano.
Nell’ambito di una ricerca più generale sul rapporto tra attività produttiva e salute, anche questa indagine viene supportata da un importante lavoro sul terreno: visite nelle “manufactures” e verifiche sistematiche a largo spettro tra i soggetti coinvolti nell’indagine. Sette anni dopo, sempre a partire da un assiduo e sistematico lavoro sul terreno, Parent pubblica il suo capolavoro: un libro sulla prostituzione parigina, De la prostitution dans la ville de Paris, che conobbe altre due edizioni (1837 e 1857), sempre corredate da una preziosa Notice Historique sull’autore scritta da François Leuret.
Impegnato soprattutto nella sfera del privato, Blanche era senza dubbio tagliato fuori da questo livello, che invece Leuret conosceva e praticava, forte della sua relazione privilegiata con Esquirol. Tale relazione, anche se contestata e delegittimata da Blanche, come si è visto, rimase comunque molto stretta: ben conosciuta e ufficialmente riconosciuta da tutto l’establishment medico-psichiatrico.
É Leuret, non a caso, ad aprire il numero del 1841 delle AHP con un elogio di Esquirol, morto l’anno prima: un commosso ricordo di colui che egli presenta pubblicamente come maestro e come guida morale. Nello stesso anno, la “Gazette médicale de Paris” pubblica un elogio dello stesso tenore scritto sempre da Leuret. Egli è dunque vicino al maestro sino alla fine: lo testimonia, tra l’altro, un suo articolo consegnato alle AHP nel 1840 e scritto in collaborazione con Esquirol, che firma così uno dei suoi ultimi testi. Sempre nel 1840, questa vicinanza viene testimoniata, paradossalmente, proprio da Esprit Blanche nella sua seconda e durissima requisitoria contro Leuret – De l’état actuel du traitement de la folie en France (à propos du dernier ouvrage de M. Leuret) – dove l’autore, rivolgendosi direttamente al suo avversario, definisce Pinel ed Esquirol “i nostri comuni maestri” (p. 10).
E’ chiaro, in ogni caso, che per difendere il system of soothing sia Blanche che Brierre privilegiano un riferimento forte alla lezione di Pinel e di Esquirol, pur non sottovalutando la difficoltà di applicare anche ai “grandi asili” la loro proposta innovativa. Scrive infatti Brierre: “L’applicazione della vita di famiglia è meno facile nei grandi asili, dove i malati si contano a centinaia; anche lì, tuttavia, essa può essere realizzata, in una certa misura, frammentando in piccoli centri questa massa considerevole di alienati e collocando ognuno di essi sotto la sorveglianza di istitutori e di istitutrici preparati a questa missione e convenientemente retribuiti”. Consapevole dell’imprescindibile dimensione corale della terapia, l’autore valorizza anche alcuni “aiuti intelligenti”: alcune figure ausiliarie (“infermieri”, “sorveglianti”, “istitutori” e “istitutrici”) indispensabili alla cura e alla presa in carico dei pazienti, anche se subordinate all’autorità indiscussa del médecin-directeur, del médecin en chef ; figure ausiliarie alle quali, secondo Brierre, è necessario prodigare riconoscimenti – ad esempio una “distinzione onorifica” – ed assegnare una “pension de retraite” (UT, 63-64).
Ambizioni riformatrici, dunque, realizzate nell’ambito del privato e riproposte – invano! – anche per i manicomi pubblici.
Ma il trattamento morale individualizzato, più facile nelle piccole dimensioni della clinica privata, viene ben presto negato come prospettiva terapeutica esemplare: ufficialmente riconosciuto – se non altro per tributare un omaggio rituale all’autorità dei suoi padri fondatori (Pinel ed Esquirol) – verrà in realtà considerato, attorno alla metà del XIX secolo, un’opzione difficilmente realizzabile e comunque meno importante del trattamento morale applicato alle masse (Parchappe) praticabile nei grandi asili.
Nel 1853 Maximien Parchappe, “Inspecteur général du Service des aliénés”, dedica non a caso il suo libro più importante al problema della fondazione e della costruzione degli asili. Facendo il punto sulla discussa e discutibile legittimità del piccolo manicomio, cioè di un asilo destinato al ricovero di circa cento alienati, egli sostiene, entro un’ottica attenta alla gestione della santé publique, che una simile realizzazione non può che gravare in maniera eccessiva sulla finanza pubblica. Un problema di costi, dunque, ma anche una questione di principio. Se si edificassero tanti piccoli asili solo per il ricovero di alienati curabili, il manicomio pubblico non sarebbe più una maison de traitement: diventerebbe una maison de refuge destinata alla custodia di pazzi considerati incurabili, ai quali verrebbe sottratta ogni speranza di miglioramento. In tale prospettiva, la casa di rifugio significherebbe, per gli internati, un’inaccettabile “condanna alla disperazione”. Parchappe ammette che possano essere predisposti spazi appositi, concepiti come “succursali degli asili principali”, per il ricovero di idioti, imbecilli, dementi, epilettici e “malpropres” (sudici, nei testi italiani coevi di psichiatria), da lui considerati estranei alla “follia propriamente detta”. Ma si tratta, aggiunge ambiguamente, solo di una “risorsa eccezionale”. Per quanto riguarda l’ambito specifico della follia, egli contesta, dunque, sia il “principio di separazione” tra curabili e incurabili sia la conseguente erezione di piccoli asili pubblici destinati a un numero limitato di alienati curabili.
La vigenza della “séparation” renderebbe più difficile una corretta valutazione differenziale, impedendo al medico “di pronunciarsi positivamente sulla curabilità o l’incurabilità della malattia”.
Non solo: poiché nella maggioranza dei casi gli alienati incurabili sono “tranquilli” e rappresentano “l’elemento più disciplinabile” all’interno dell’asilo, è possibile, agendo sul “contagio dell’esempio”, riuscire a “spegnere l’agitazione e le tendenze eccentriche che fanno parte dei sintomi della follia acuta e curabile”.
Per rafforzare le sue argomentazioni sfavorevoli al “principe de la séparation”, Parchappe aggiunge al primo capitolo del suo libro un’interessante appendice, dove passa in rassegna alcune posizioni attorno a questo problema: quasi tutte sfavorevoli al “principe”. Vari gli autori menzionati nell’appendice. Tra questi anche Maximilian Jacobi (1775-1858), direttore dell’asilo di Siegberg, vicino a Bonn, che nel 1834 aveva pubblicato il suo libro più importante – dedicato alla costruzione e alla direzione delle maisons d’aliénés – tradotto in inglese sette anni dopo da Samuel Tuke. Jacobi, ammiratore dei Tuke e del trattamento morale praticato alla famosa York Retreat, concepisce l’asilo per alienati solo come casa di trattamento per pazienti curabili, sostenendo che gli incurabili devono essere sempre – e non solo in via eccezionale – destinati a case di rifugio, a “case di sicurezza”.
Il primo autore menzionato nell’appendice è l’Esquirol autore del Mémoire presentato al Ministro dell’Interno nel 1818 (Des établissements d’aliénés en France et des moyens d’améliorer le sort de ces infortunés) e poi ripubblicato nel Des maladies mentales del 1838. Questo importante scritto, definito correttamente da Gauchet e Swain “un’arringa in piena regola a favore della costituzione di asili di vaste dimensioni”, viene frainteso da Parchappe, che lo cita come esempio di una posizione favorevole ai piccoli asili e al “principe de séparation”. Esquirol, è vero (e da qui nasce l’equivoco), parla della possibile creazione di “un piccolo numero di établissements – cito e traduco il passaggio riportato da Parchappe – in ognuno dei quali si potrebbero riunire da 150 a 200 alienati curabili messi in trattamento; questi établissements servirebbero da modello, da scuola di istruzione e da oggetto di emulazione per le altre maisons”. Dopo aver ventilato questa possibilità – una via di mezzo tra la piccola casa di cura e la prospettiva strategica del grande asilo – Esquirol presenta in maniera molto critica, in passaggi non citati da Parchappe, alcune proposte già emerse, ad esempio ad Albi e a Poitiers, che prevedevano la creazione di “un ospedale per dipartimento […] costruito per un piccolo numero di alienati, ad esempio trenta, quaranta, sessanta”. Soluzioni senza dubbio inaccettabili per Esquirol: dispendiose e del tutto inadeguate rispetto all’ambizione della psichiatria nascente, che puntava – nell’ottica di un miglioramento della santé publique, di una normalizzazione delle condotte devianti, di una difesa della sicurezza sociale – ad intercettare una domanda di cura estesa, generalizzata, largamente presente soprattutto nelle famiglie con congiunti a carico affetti da gravi disturbi mentali. Al contrario, “costruendo grandi établissements – afferma ancora Esquirol –, collocandoli e distribuendoli convenientemente, si otterranno risultati utili per coloro che verranno ricoverati, economici per l’amministrazione”.
Il trattamento morale, in definitiva, deve essere gestito entro una logica dei grandi numeri: un trattamento morale di massa, dunque, più che un trattamento morale individualizzato, come quello sperimentato da Blanche, da Brierre e dallo stesso Esquirol in rue de Buffon. Un trattamento morale affidato sempre di più al funzionamento della disciplina, delle regole impersonali e delle norme che scandiscono la vita dell’asilo. La fiducia nelle capacità terapeutiche di un medico-direttore che vive con i suoi malati – un importante motivo conduttore dell’opera di Esquirol, ben presente nei lavori di molti suoi seguaci – viene sostituita dalla fiducia accordata a una centralizzazione efficace, sostenuta dalla forza impersonale del regolamento, da una struttura architettonica funzionale alle compartimentazioni della nosografia, da una rete di sorveglianti capaci e persuasivi: fattore decisivo, quest’ultimo, che garantiva l’agibilità di una linea dirigista e centralizzatrice. Una linea ben interpretata, ad esempio, in assoluta continuità con le posizioni di Parchappe, da un Jean Pierre Falret (1794-1870), cioè da colui che nel 1854, liquidando la monomania esquiroliana, elaborò, contestualmente alla folie circulaire di Baillarger, il concetto di folie à double forme, non esitando a dichiarare, a proposito della conduzione degli asili: “Mi si diano degli asili ben costruiti e dei buoni sorveglianti, e io dirigerò, dalla capitale, tutti gli établissements di alienati della Francia”.
Attorno alla metà del secolo ha già preso corpo un’ottica dirigista, capace di soppiantare la dimensione qualitativa, empatica e “morale” della prima alienistica e dei suoi médecins-philosophes. La nascita della psichiatria moderna, con Pinel, era stata scandita dalla figura del medico-filosofo, particolarmente attento alla relazione tra il physique e il moral dei ricoverati. Ma questa figura viene ben presto rimpiazzata da quella del medico-amministratore, che unifica, obbedendo alla legge del 1838, l’istanza terapeutica e quella economico-gestionale.
E’ quindi molto probabile che il primo obiettivo della polemica di Parchappe attorno al principio di separazione fosse proprio il superamento di una curvatura individuale, qualitativa – potremmo anche dire, con voluto anacronismo, psicoterapica – della cura.
Nella prospettiva del trattamento morale di massa occorreva assegnare un largo spazio all’ergoterapia nascente, anche attraverso la costruzione di una fattoria adiacente all’asilo, come aveva già auspicato Esquirol: questa fattoria coltivata dagli alienati – definiti per la prima volta travailleurs dall’Esquirol del 1840 – venne in sèguito realizzata in molti asili europei: ad esempio da Ferrus a Bicêtre e da Parchappe a Saint-Yon, per citare solo due importanti esempi francesi. Nel suo Discours del 1862, in coerenza con questa prospettiva, Parchappe arriva infatti a chiedersi: “Nei laboratori e nelle fattorie dei nostri asili ci si deciderà” finalmente, “con il pretesto della fondazione di colonie di alienati, a sostituire la dotta e benefica utilizzazione del lavoro industriale e del lavoro agricolo per il trattamento curativo e palliativo della follia con vere imprese di industria agricola”?
La cura, come si vede, perde la sua centralità, oltre che la sua specifica caratterizzazione relazionale, per diventare variabile dipendente di una macchina organizzativa e produttiva. L’alienista inglese Ellis ci informa ad esempio che nel manicomio di Hanwell, da lui diretto, su 610 ricoverati, 450 lavorano, dedicandosi anche a mestieri nuovi che non praticavano prima dell’internamento. L’asilo che “guarisce” è dunque macchina disciplinare e produttiva. O meglio: l’asilo assolve alla sua funzione terapeutica solo nella misura in cui diventa apparato produttivo, macchina disciplinare, dispositivo ergonomico.
Ad una nuova figura – quella dell’alienato travailleur – corrisponde la figura dell’alienista medico-direttore, responsabile sia delle terapie che della gestione e dell’amministrazione degli alienati. Il medico-direttore, a sua volta, viene sottoposto al controllo di un collega che è stato promosso ispettore generale (Ferrus e Parchappe, ad esempio), diventando così, come è stato detto polemicamente, fonte di informazioni e di consigli per il ministro della Salute: “œil du ministre”, occhio del ministro, che spesso, per fini politici o personali, scavalca il medico-direttore raccogliendo informazioni sull’asilo in questione da subalterni trasformati in spie (“subalternes”, come scrive polemicamente Belloc, che diventano spie, “mouchards”).
Trattamento morale di massa, ergoterapia, utilizzazione degli alienati come forza-lavoro, come travailleurs: siamo agli antipodi di quella che abbiamo definito terapia qualitativa, giocata sui piccoli numeri. Blanche viene praticamente ignorato dopo la morte di Esquirol. Brierre de Boismont, rompendo una sorta di congiura del silenzio, lo aveva citato generosamente come uno dei suoi ispiratori: oltre che nel testo del 1866, da noi più volte ricordato, anche in una pubblicazione molto interessante del 1836, dedicata alla costruzione degli hospices d’aliénés ma già decisamente orientata verso la prospettiva strategica del grande asilo.
Nella psichiatria pubblica, in ogni caso, lo stile terapeutico perorato da Blanche perderà definitivamente la sua funzione di modello già a partire dalla metà del secolo XIX.
Nel suo testo del 1836, presentando l’uso produttivo degli alienati come risorsa indispensabile di un “grand établissement”, Brierre si fa interprete di una transizione cruciale – dal criterio qualitativo al criterio quantitativo – relativamente alla cura e alla gestione dei pazienti. Egli adotta, in definitiva, posizioni che troveranno la loro prima formulazione compiuta poco prima della metà del secolo, con alienisti come Guillaume Ferrus (1784-1861) e Maximien Parchappe (1800-1866), entrambi – il primo dal 1835, il secondo dal 1848 – ispettori generali delle maisons d’aliénés.
Il lavoro, dunque, al centro di questo passaggio dal qualitativo al quantitativo. Un lavoro, come scrive Brierre riferendosi agli alienati, capace di modificare “la catena viziosa delle loro idee”. Un lavoro concepito come energia diversiva rispetto al delirio e insieme come strumento dell’ordine e della disciplina. Un mezzo, uno strumento, ma anche un fine. “Un lavoro meccanico rigorosamente eseguito” – precisa Brierre riprendendo Pinel – serve a “mantenere la polizia interna”. La police intérieure, la disciplina, l’obbedienza: condizioni di possibilità del lavoro e al tempo stesso sue finalità, suoi effetti, suoi esiti conseguenti.
5. Lavoro e disciplina
Un’attenta riflessione sul rapporto tra lavoro e disciplina nel contesto asilare può rendere obsoleta la polarizzazione ideologica esclusione-inclusione presente in alcune critiche che sono state rivolte, soprattutto in Francia, al Foucault archeologo e genealogista della follia: un Foucault che diventa – ad esempio per Marcel Gauchet – l’ideologo di un potere concepito univocamente come strategia dell’esclusione.
In realtà, i folli internati – e tra questi le figure dell’aliéné-travailleur – proprio in quanto bersagli di un potere disciplinare, sono al tempo stesso esterni e interni, esclusi e inclusi: portatori di un’alterità investita dalle regole dell’istituzione e dalle normative del lavoro e per questo stesso motivo più ridotta, meno dissimile, meno distante. Nella prefazione di Les mots et les choses (1966) questa complessa duplicità è stata efficacemente sintetizzata in un passaggio che vale forse la pena rileggere in lingua originale:
“L’histoire de la folie serait l’histoire de l’Autre, de ce qui, pour une culture est à la fois intérieur et étranger, donc à exclure (pour en conjurer le péril intérieur) mais en l’enfermant (pour en réduire l’altérité) ”.
In questo passaggio, il verbo enfermer, presente in forma gerundiva, non corrisponde certamente né al verbo exclure né al verbo inclure.
Da un lato, tra rinchiudere e includere esiste un significativo dislivello semantico: se l’inclusione rinvia a una modalità del coinvolgimento e dell’inglobamento, l’atto del rinchiudere non possiede di per se stesso queste implicazioni positive. E’ più secco, più brutale, più spoglio.
Dall’altro lato, Foucault usa qui il verbo enfermer per indicare uno spazio disgiuntivo, un’azione raddoppiata. Ti rinchiudo non, sic et simpliciter, per sottrarti al mondo, per escluderti dai circuiti della socializzazione (azione repressiva e puramente negativa): in questo senso, enfermer non è un atto di mera esclusione. Non corrisponde a exclure. Ti rinchiudo, in realtà, riconoscendoti come individuo straniero al mio mondo ma nel contempo interno ad esso. In definitiva ciò significa: ti rinchiudo per coinvolgerti subito dopo, al fine di “ridurre la tua alterità”.
Anche se si accettano tali premesse, è necessario ribadire che la proposizione icastica e riassuntiva “ti rinchiudo per ridurre la tua alterità” non equivale comunque all’altra possibile proposizione icastica e riassuntiva: “ti includo per ridurre la tua alterità”. É assente, nella seconda, la dimensione dell’atto di forza, che può essere, tutt’al più, intravisto o sospettato. E’ forse troppo debole, nella prima, la centralità dell’atto positivo di coinvolgimento. Ciò significa che la tessitura discorsiva a cui appartiene enfermer è distante sia da una concezione giuridico-repressiva del potere – bersaglio privilegiato del riformatore radicale o del rivoluzionario – sia da una concezione democratica e neoliberale del potere, magari ricoperta da una vernice ideologica buonista e umanitaria. Distante, quindi, da due affermazioni di segno contrario: “ti rinchiudo per escluderti” e “ti includo per conoscerti”, per dialogare con te, per curarti.
Tra le due proposizioni icastiche appena menzionate, la prima è quella più vicina al dettato di Foucault: in altre parole, per ridurre la tua alterità devo usare la forza e rinchiuderti. Al tempo stesso, mi sembra questa la formulazione più aderente alla realtà storica dell’asilo: quel singolare ossimoro dove i contrari si toccano e interagiscono. Dove forza e inclusione convivono. Dove répression e douceur – lo scriveva Pinel, come vedremo, nel 1805 – si intrecciano indissolubilmente. Dove appareil de force e trattamento morale – lo scriveva Esquirol, come si è visto, sempre nel 1805 – si incontrano e inevitabilmente si coniugano.
L’inclusione, la douceur e il trattamento morale, anche se sistematicamente collegati ai loro contrari, rappresentano comunque la testimonianza eloquente di un funzionamento positivo del potere nei confronti della follia: cioè di una follia che Foucault vede, nel 1983 – quando delinea, un anno prima della morte, una sorta di sintetico bilancio delle sua ricerca – come “esperienza all’interno della nostra cultura”, come “punto a partire dal quale si è formata una serie di saperi più o meno eterogenei” (la medicina, la psichiatria, la psicologia, la sociologia, eccetera). Una follia, insomma, come “matrice di conoscenze”, da studiare nelle “forme di sviluppo” che le caratterizzano. Di più: una follia come “fenomeno di devianza”, come “matrice di comportamenti”, come “esperienza” che “definisce la costituzione di un certo modo di essere del soggetto normale”.
Vedere questa positività all’interno dei meccanismi che definiscono il potere psichiatrico significa cogliere, in tutta la sua articolata contraddittorietà, l’aspetto duplice dell’asilo. L’asilo come Giano bifronte, come ossimoro, come figura ambigua.
Certo. Se Foucault avesse valorizzato l’esperienza dell’aliéné travailleur, la specificità materiale e istituzionale dell’ossimoro asilare sarebbe forse emersa con maggior chiarezza lungo tutto l’arco dei suoi interventi dedicati al mondo della follia. D’altra parte, se Gauchet e Swain avessero esaminato con attenzione la svolta “ergonomica” dell’alienistica ottocentesca, avrebbero forse evitato un’enfasi ideologica eccessiva attorno al sujet de la folie, a vantaggio di una effettiva comprensione della sua stretta appartenenza a un reticolato disciplinare: del suo essere oggetto e destinatario – non solo passivo e non sempre unico – di un potere disciplinare. Cercherò di spiegarmi meglio.
La categoria del lavoro produttivo, in effetti, è particolarmente adatta a esibire l’insopprimibile e costitutiva ambivalenza dell’asilo ottocentesco, nel quale lavoro e disciplina hanno funzionato dentro una relazione circolare. Un lavoro che crea disciplina. Una disciplina che rende possibile il lavoro. Il lavoro come forza produttiva, potenzialmente emancipativa e risocializzante. Al tempo stesso, il lavoro come forza assoggettata, sottoposta ai vincoli di una regola generale e impersonale: talora introiettata, molto spesso imposta. Introiettata nel caso dei convalescenti, pronti a completare nel mondo esterno il loro processo di risocializzazione. Imposta nel caso dei malati gravi, cronici e incurabili, trascinati dalla forza persuasiva dell’esempio – l’esempio di altri pazienti docili e disponibili al lavoro – e dall’autorità morale del medico.
L’imposition du travail, di cui parla Parchappe nel già citato Rapport del 1841, non può ovviamente passare attraverso l’uso degli apparati di forza e della coercizione fisica gestita dagli addetti alla sorveglianza: un trattamento, questo, destinato solo a una parte dei pazienti refrattari alla regola del lavoro. Secondo le stime riportate da Parchappe nel 1865, il 25% della popolazione internata era esclusa dalle attività lavorative. All’interno di questa percentuale, ovviamente, vi erano i furiosi, i violenti e gli irriducibili, controllati attraverso l’isolamento e i mezzi di contenzione.
Nel perimetro asilare il lavoro funziona come operatore di un passaggio cruciale, ben analizzato da Foucault nel Potere psichiatrico: dall’esercizio dispotico della sovranità al potere disciplinare. Dall’uso diretto della repressione all’adozione, per certe fasce della popolazione internata, di una disciplina: capace non solo di assoggettare ma anche di in-formare, di investire positivamente e di plasmare i soggetti internati. Di investirli in quanto individui appartenenti a una massa, a una popolazione. La posizione ufficiale di Parchappe era affiancata da punti di vista più radicali. Quello, ad esempio, di Hippolyte Belloc, su cui tornerò in sèguito: vero e proprio attivista della nascente “ergoterapia” asilare, medico-direttore dell’asilo dipartimentale di Alençon, oltre che membro del “Consiglio di sorveglianza del lavoro dei bambini nelle manifatture”, egli si batte per la trasformazione degli asili in centres d’exploitation rurale. Censurato dallo stesso Parchappe, diventa, come Eugène Billod, un fervente sostenitore della fattoria-asilo, della Ferme-Asile, fino al punto da adottare una prospettiva utopica, assegnando alle colonie agricole il ruolo di panacea e di antidoto a tutte le insufficienze e a tutti gli abusi della psichiatria istituzionale. Per gli alienisti francesi dell’epoca, la Ferme-Asile di Sainte-Anne, collegata a Bicêtre e fondata da Ferrus nel 1828, divenne il prototipo esemplare della colonia agricola manicomiale. L’alienato – il travailleur, come lo chiama volentieri Belloc nel suo testo programmatico del 1862 – deve essere spinto al lavoro da esortazioni, da iniziative capaci di stimolare in lui uno spirito di emulazione, e infine da una vera e propria educazione agricola, che deve essere regolarmente impartita attraverso scuole appositamente organizzate nell’asilo. Evidente, qui, la distanza tra posizione realistica e prospezione utopica: tra l’imposizione del lavoro sostenuta e praticata da Parchappe e l’educazione al lavoro predicata da Belloc. Come dire, tra una disciplina che i pazienti subiscono, in quanto corpi ricettivi da assoggettare, e una disciplina che i pazienti dovrebbero introiettare, in quanto individui dotati di un mondo interno da penetrare: dotati di uno spazio interno difficilmente accessibile – al quale farò riferimento al termine di questa analisi – che certi medici, molto prima della psicoanalisi, pensarono e sperarono di poter conoscere, dirigere e in-formare.
Verso la metà del secolo, attorno alla figura dell’alienato-lavoratore viene verificata – da Brierre a Parchappe, per non citare che loro – un’intima solidarietà tra lavoro e disciplina. Si tratta di una complementarietà che Karl Marx metterà a fuoco negli stessi anni per il sistema della fabbrica (il Primo Libro del Capitale, non lo si dimentichi, esce nel 1867): non si dà corpo produttivo che non sia corpo assoggettato. In altri termini, solo un corpo docile e disciplinato può essere funzionale al sistema della fabbrica: più in generale, al sistema dell’atelier, dell’ufficio, dell’impresa agricola, dell’ospedale. Anche dell’asilo, secondo la nostra ipotesi. Innegabile, a questo livello, la necessità di riproblematizzare – soprattutto in rapporto ai temi qui affrontati – il nesso tra Foucault e Marx: più specificamente, il tema della relazione tra processi di disciplinamento e processi produttivi; in un orizzonte più largo, la relazione tra genealogia e critica dell’economia politica, che qui mi limito a indicare.
L’ “operaio complessivo”, il Gesamtarbeiter in quanto “operaio socialmente combinato” – cito dal Terzo Libro del Capitale – ha bisogno della disciplina: “il capitalista riesce a imporre” questa disciplina “agli operai combinati”, cioè raggruppati in grandi numeri e organizzati ai fini della produzione tramite una “preparazione” adeguata e un opportuno “addestramento”. E’ ovvio che tale “disciplina” diventa “superflua in un sistema sociale in cui gli operai lavorino per se stessi”.
Nella fabbrica la disciplina rende possibile la produzione. Essa è insomma forza produttiva. Marx lo spiega nel Primo Libro del Capitale (in specie nel capitolo undicesimo: Cooperazione; nel capitolo dodicesimo: Divisione del lavoro e manifattura e nel capitolo tredicesimo, il più celebre: Macchine e grande industria). Egli esalta infatti la potenza del capo – “die Macht des “Meisters”(master)” – assegnandogli una funzione direttamente produttiva. Capo, maître, Meister, master: una funzione di comando agisce come funzione direttamente produttiva e come condizione di possibilità dell’estrazione di plusvalore. Figura essenziale, dunque, da cui dipende il funzionamento di una disciplina quasi da caserma (“kasernenmäßige Disziplin”), fatta di controllo, di addestramento, di punizioni. E il registro delle punizioni del sorvegliante (“das Strafbuch des Aufsehers”) sostituisce, nella fabbrica, la frusta del negriero (“der Peitsche des Sklaventreibers”). Allo stesso modo, potremmo aggiungere, la disciplina manicomiale – con le sue regole, le sue ingiunzioni e le sue nuove forme di coercizione – sostituisce le antiche catene.
Come spiega Foucault in un testo cruciale, solo apparentemente minore, Marx si distacca radicalmente da una “concezione giuridica del potere”: da una concezione formale e giuridico-repressiva del potere, elaborata “a partire dalla legge e dal sovrano, a partire dalla regola e dalla proibizione”.
In questa sua analisi, Foucault fa riferimento, solo attraverso un cenno fugace, al Secondo Libro del Capitale: qui, in effetti, il “ciclo del capitale”, definito come “processo periodico”, è condizionato dalla composizione del capitale produttivo, dalla durata della produzione e dalla durata della circolazione. Perciò la disciplina e le relazioni di potere inerenti il rapporto di produzione – oggetto specifico dell’analitica marxiana nel Libro Primo – diventano, in tale contesto, momenti direttamente implicati dal “tutto” rispetto al quale la “giornata lavorativa” rappresenta soltanto una parte. Una parte costitutiva e fondante, certo, ma comunque una parte, sulla quale si esercita l’influsso determinante del “periodo di lavoro” (cap. XII), del “tempo di produzione” (cap. XIII), del “tempo della circolazione” (cap. XIV): il genealogista lettore del Capitale trova proprio qui, molto probabilmente, un concerto di grandezze economiche e di poteri specifici ad esse strettamente correlati; un arcipelago di poteri differenti – potremmo dire riprendendo il testo di Foucault Les mailles du pouvoir [che citeremo come MP] – che producono, al tempo stesso, merci e assoggettamento.
In ogni caso, pur non approfondendo questo suo riferimento privilegiato al Secondo Libro del Capitale, Foucault riconosce a Marx una straordinaria capacità di analizzare il potere nei suoi “meccanismi positivi” (MP, 186).
Per farlo, egli afferma, è necessario sbarazzarsi della concezione repressiva del potere, oggi molto diffusa, ad esempio, tra gli psicoanalisti – da Melanie Klein a Winnicot, fino a Lacan – per i quali “il significato del potere, il punto centrale in cui consiste il potere è ancora la proibizione, la legge, il fatto di dire no, ancora una volta la forma, la formula tu non devi. Il potere è essenzialmente chi dice tu non devi” (MP, 183). Anche negli studi etnologici, da Durkheim a Lévi-Strauss, la concezione repressiva si è imposta attraverso la centralità assegnata alla proibizione dell’incesto. A questa etnologia della regola e della proibizione si è contrapposta una nuova visione del potere, ad esempio “con i lavori di Pierre Clastres”: una nuova visione che “cerca di emanciparsi dal primato, da questo privilegio della regola e della proibizione” analizzando il potere come istanza produttiva, come “tecnologia” (MP, 184). Lungo questa strada – laddove prevale “l’analisi del potere nei suoi meccanismi positivi” (MP, 186) – Foucault incontra e utilizza l’analitica marxiana.
Foucault: ciò che possiamo trovare nel Secondo Libro del Capitale è, in primo luogo, che non esiste un potere, ma parecchi poteri. Poteri significa forme di dominazione, forme di sudditanza, che funzionano localmente, ad esempio nell’officina, nell’esercito, in una proprietà di tipo schiavista o in una proprietà in cui vi sono relazioni servili. Queste sono tutte forme locali, regionali di potere, che hanno il loro specifico modo di funzionamento, la loro procedura e la loro tecnica. Tutte queste forme di potere sono eterogenee. Marx insiste molto, ad esempio, sul carattere al tempo stesso specifico e relativamente autonomo, in qualche modo impermeabile, del potere di fatto che il padrone esercita in un’officina, in rapporto al potere di tipo giuridico che esisteva nel resto della società. Dunque, esistenza di regioni di potere. La società è un arcipelago di poteri differenti. Marx mostra come, a partire dall’esistenza iniziale e primitiva di queste piccole regioni di potere – la proprietà, la schiavitù, l’officina e anche l’esercito – si siano potuti formare, poco a poco, grandi apparati di Stato. Esemplari, per Foucault, le “superbe analisi” di Marx sul “problema della disciplina nell’esercito e nelle fabbriche” (MP, 186-187). Al di là del significativo apprezzamento, occorre osservare che la centralità marxiana della fabbrica, epicentro del modo capitalistico di produzione, viene qui ignorata, a profitto di una lettura orientata a includere Il Capitale in una concezione pluralista e policentrica del potere. Lettura parziale, certo, ma felicemente estranea a ogni presunto “ritorno a Marx” che funzioni come “anestesia neutralizzante”, dove il registro interpretativo – filologico, filosofico, scientifico, in ultima analisi accademico – finisce per produrre ciò che giustamente Jacques Derrida critica e ridicolizza: e cioè il “passar sotto silenzio” il potenziale sovversivo del testo marxiano, la sua intrinseca appartenenza ad un’idea di trasformazione radicale, ad un’idea di cambiamento del mondo. Foucault rilegge Marx, fuori da ogni preoccupazione accademica, per consolidare la sua analitica del potere: un’analitica innovativa, concepita come momento di rottura rispetto a visioni tradizionali, di impianto giuridico-repressivo, largamente presenti nelle scienze dell’uomo (cfr. J. Derrida, Spectres de Marx, Galilée, Paris 1993).
Vi è un elemento saliente nei dispositivi disciplinari tematizzati nel testo Les mailles du pouvoir: “una grande unità piramidale”, una struttura gerarchica di tipo piramidale “con tutta una serie di capi intermediari, di sottoufficiali, di tecnici anche”. E’ proprio la figura intermedia del contremaître – il capo nella fabbrica, il sorvegliante nell’asilo – quella che garantisce efficienza e produttività all’intero sistema, facendo funzionare in forme specifiche e adeguate un’effettiva “divisione del lavoro”. In questa prospettiva, l’analisi marxiana del sistema-fabbrica diventa paradigmatica. Può estendersi, per analogia, all’esercito, o al sistema educativo – è ciò che Foucault propone in questo testo – ma anche, in una certa misura, all’asilo.
“La divisione del lavoro è stata, al tempo stesso, la ragione per cui si è stati obbligati ad inventare questa nuova disciplina di fabbrica; ma, inversamente, possiamo dire che la disciplina di fabbrica è stata la condizione che rende possibile la divisione del lavoro. Senza questa disciplina di fabbrica, cioè senza la gerarchia, senza la sorveglianza, senza l’apparizione dei contremaîtres, senza il controllo cronometrico dei gesti, non sarebbe stato possibile ottenere la divisione del lavoro” (MP, 188-189).
Un fondamentale passaggio logico e storico – che ci permette di utilizzare tale approccio anche per la questione dell’asilo – è quello affrontato da Foucault nella parte finale di questo testo straordinario, oltre che, ovviamente, in tutti i suoi interventi sulla biopolitica.
A partire dal secolo XVIII, le diverse dimensioni locali del potere, dove prendono forma specifici e puntuali assetti disciplinari, mettono in gioco “tecnologie che non puntano agli individui in quanto individui, ma che prendono di mira, al contrario, la popolazione”. E ancora: “si scopre che ciò su cui il potere si esercita è la popolazione”, e cioè “degli esseri viventi attraversati, comandati, governati da processi, da leggi biologiche. Una popolazione ha un tasso di natalità, di mortalità, una popolazione ha una curva d’età, una piramide d’età, una morbilità, uno stato di salute, una popolazione può perire o può, al contrario, svilupparsi” (MP, 193). E quindi, “a partire da qui, tutta una serie di tecniche d’osservazione, tra le quali evidentemente la statistica, ma anche tutti i grandi organismi amministrativi, economici e politici sono incaricati di questa regolazione della popolazione. Vi sono due grandi rivoluzioni nella tecnologia del potere: la scoperta della disciplina e la scoperta della regolazione, il perfezionamento di una anatomo-politica e il perfezionamento di una bio-politica”. La vita stessa è diventata bersaglio privilegiato del potere. “Ci sono dei corpi e delle popolazioni. Il potere è diventato materialista. Cessa di essere essenzialmente giuridico. Deve trattare con cose reali che sono i corpi, la vita. La vita entra nel dominio del potere: mutazione capitale, una delle più importanti, senza dubbio, nella storia delle società umane” (MP, 194).
Anche all’interno del perimetro manicomiale, in relazione al controllo, all’amministrazione e alla terapia degli alienati, vediamo maturare, già a partire dal primo ottocento, il passaggio da una anatomo-politica a una biopolitica: bersagli della disciplina e della cura non saranno più i singoli malati considerati come individui a sé stanti, ma l’insieme dei malati considerati come popolazione: una popolazione da amministrare e da regolare anche attraverso l’uso dell’approccio statistico, largamente presente nei testi psichiatrici ottocenteschi, a cominciare da Pinel e da Esquirol.
Indicazioni anamnestiche, provenienza sociale, attività lavorativa, stato di salute, diagnosi, terapie, curve d’età, tassi di mortalità: sono tutti dati sistematicamente raccolti dagli alienisti e inseriti nelle Tavole statistiche che accompagnano i rapporti sanitari pubblicati periodicamente dai direttori degli asili. Conseguentemente, il trattamento morale, lo si è già visto, diventa sempre di più un metodo terapeutico applicato alla massa dei ricoverati, piuttosto che un sistema di cura individuale destinato al singolo internato. O meglio: il trattamento del singolo verrà filtrato e reso possibile da un approccio alla molteplicità, al gruppo, alla massa.
Nell’esercito, nel sistema scolastico e nella fabbrica, “gli individui – come scrive Foucault – sono individualizzati nella molteplicità”: sono bersagli di una “individualizzazione del potere” (MP, 192), alla quale, a partire dal secondo settecento, succede una nuova “famiglia di tecnologie del potere” (MP, 193) che investe la popolazione. Nell’asilo l’intervallo temporale tra questi due momenti è davvero molto esiguo. Può anche accadere, a volte, che essi si presentino affiancati, sovrapposti oppure vicinissimi nel tempo, o addirittura presenti nell’opera di uno stesso autore. La parabola dello stesso Pinel, dalla prima alla seconda edizione del suo Traité (cioè dal 1800 al 1809), ci pare, in questo senso, esemplare: nel volgere di pochi anni viene rivolta una nuova attenzione alla massa degli alienati, oltre che al malato singolo. Eloquente testimonianza di tale passaggio: la presenza, nella seconda edizione del Traité, di un lungo capitolo inedito, dedicato significativamente, come si è già ricordato, alla Police intérieure des asiles.
In ogni caso, non mi sembra azzardato proporre, ora, un fertile parallelismo: lo spazio occupato dalla follia nella realtà manicomiale è analogo, anche se in proporzioni differenti, allo spazio occupato dal sesso, secondo Foucault, nelle società occidentali moderne. E’ proprio la lettura di un testo insolito e stratificato come Les mailles du pouvoir che mi ha spinto ad azzardare questo gioco di parallelismi: come il sesso, che Foucault considera uno “strumento di disciplinarizzazione”, si situa, nelle società moderne, “alla cerniera tra l’anatomo-politica e la biopolitica”, e dunque “all’incrocio tra le discipline e le regolazioni” (MP, 194), così, su scala più ridotta, il folle, all’interno del sistema manicomiale, viene costruito, fabbricato, costituito come strumento e come ingranaggio fondamentale dell’assoggettamento. Gestito come uno degli “atomi sociali” (MP, 191) che compongono la collettività dei pazienti – quella che Parchappe chiama la massa dei pazienti – il folle si situa al crocevia tra le tecniche di individualizzazione del potere e la biopolitica. Questo accade proprio nel momento in cui egli diventa componente riconosciuta di una forza lavoro complessiva: nel momento stesso, cioè, in cui una gran parte dei malati viene considerata e trattata come popolazione potenzialmente produttiva, che deve essere perciò addestrata, disciplinata e istruita al fine di svolgere determinate mansioni lavorative. Anche qui, un micropotere – l’asilo – che funziona localmente: non tanto come apparato repressivo e come macchina dell’esclusione, quanto piuttosto come meccanismo positivo, capace di investire e di coinvolgere gli individui sottoposti alle regole del suo funzionamento.
Cercherò di rafforzare le ragioni di questo parallelismo riesaminando brevemente, proprio a partire da Pinel, la struttura disciplinare dell’asilo e il suo rapporto con la cura.
La funzione disciplinare del capo, del sorvegliante, è certamente una funzione di comando, che nell’asilo ben organizzato diventa componente essenziale del dispositivo terapeutico.
È ciò che accade fin dalle origini alla Salpêtrière, dove, già a partire dal 1802, Pinel affida a Pussin, capo dei sorveglianti, il compito di dirigere il trattamento morale delle alienate con l’aiuto della moglie. Tale importante incarico viene svolto in stretta collaborazione con il medico-direttore. Non si tratta, come è stato detto forzando il significato di un testo pineliano, di una “collaborazione paritetica tra il medico e il sorvegliante”: rileggendo attentamente quel testo siamo invece propensi a ritenere che il comando strategico dell’asilo fosse a tutti gli effetti nelle mani del medico-direttore, vero e proprio vertice di una piramide gerarchica. Vediamo.
“C’est un petit Empire qu’un hospice”, scrive Pinel in questo lucido intervento del 1805. L’ospizio è un piccolo Impero. Un piccolo Impero, certamente, dove il medico stesso è l’unico e indiscusso Imperatore, che aveva deciso di affidare a Pussin la direzione delle alienate per ciò che riguarda il trattamento morale (“la direction des aliénées au moral”). Ma proprio nella misura in cui l’ospizio è governato da un regime di dolcezza e di repressione (“régime de douceur et de répression”), anche i compiti di Pussin – cioè, come possiamo leggere, dell’ “uomo più adatto, in Francia, a cooperare con le mie concezioni” – riflettono questa duplice dimensione. Pussin, infatti, è senz’altro molto “abile” e pieno di “zelo” nell’ “arte di dissipare le illusioni degli alienati o l’oggetto del loro delirio” (dal momento che possiede anche “il felice dono di dominarli, di tenerli sotto la sua dipendenza senza perdere la loro fiducia e la loro stima”); tuttavia, con le alienate che “hanno perduto persino il senso della loro personale esistenza”, egli deve saper usare vantaggiosamente “la costrizione”, “la semplice minaccia di una reclusione e dell’uso della camicia di forza o la paura di una forte doccia”; deve saper mostrare una “fermezza inflessibile”, evitando ogni “esperienza traumatizzante” ed usando tutta la sua “esperienza” e la sua capacità di “penetrazione”, in modo che minacce e “mezzi” repressivi servano a “ristabilire la ragione” degli alienati. Non è quindi lecito, se si vuole davvero comprendere la natura ambigua del manicomio nascente, isolare solo la parte, per così dire, nobile del trattamento morale, passando sotto silenzio le sue articolazioni violente e dispotiche. Pussin, non lo si dimentichi, viene presentato da Pinel solo all’interno del secondo capitolo del suo intervento – Police intérieure et maintien de l’ordre – proprio come “capo della polizia interna”, incaricato di “eseguire le misure prescritte il mattino dal medico” e di dirigere il lavoro dei sorveglianti: “distribuzione regolare degli alimenti, mantenimento della pulizia, repressione dei disordini, delle risse e degli abusi all’interno del servizio”, “direzione prudente della sala dei bagni e delle docce” ed infine “passaggio alternato delle alienate da una ad un’altra delle tre divisioni”.
Quest’ultimo aspetto rinvia al contenuto del primo capitolo del testo pineliano (Distribution générale des aliénées dans l’hospice), dove vengono fissati criteri generali relativi all’organizzazione e alla compartimentazione degli spazi. Tre devono essere le “grandi divisioni” presenti nell’asilo: la prima destinata alle malate “agitate” e “furiose”; la seconda alle malate che hanno mostrato “un cambiamento favorevole” delle loro condizioni; la terza alle ricoverate in stato di convalescenza: stato che occorre “consolidare” attraverso il loro impiego in “un lavoro manuale”. Il medico dirige – con l’indispensabile apporto dei sorveglianti – il passaggio delle malate da una divisione all’altra, a seconda della sua valutazione del loro stato di salute.
La “prescrizione dei medicamenti”, considerata “una parte molto piccola della medicina”, è trattata – diversamente da quanto affermano Postel e Bing – solo marginalmente all’interno del terzo e conclusivo capitolo (Traitement médical), più esteso degli altri due. Pinel si dilunga, qui, sull’individuazione delle cause della malattia mentale e sulla conseguente pertinenza della diagnosi medica. Sviluppando un’analisi delle misure terapeutiche adottate, valuta la loro congruenza rispetto alla diagnosi e assegna un valore particolare, ancora una volta, alla “distribuzione in sezioni”, al “mantenimento dell’ordine” e alla “esecuzione di tutte le altre misure del trattamento morale”. L’articolo si conclude con una orgogliosa rivendicazione, supportata da dati statistici, dei successi terapeutici ottenuti alla Salpêtrière, dove il rapporto tra guariti e ricoverati è “di uno a due”, contro il rapporto “di uno a tre” dell’Inghilterra.
Già nella sua fase aurorale, dunque, la psichiatria manicomiale gioca gran parte delle sue carte – agli occhi della pubblica amministrazione, del ceto medico e dell’opinione pubblica – sulla centralizzazione del comando, resa possibile da una rete di sorveglianti e di employés che dipende strettamente dalla volontà del médecin en chef, cioè di colui che di questo stesso comando rappresenta la fonte assoluta e il vertice indiscutibile. Secondo l’opinione condivisa da tutto l’establishment psichiatrico, il successo terapeutico è garantito dalla vigenza effettiva di questo comando centralizzato e anche, conseguentemente, dalla buona armonia che regna tra le cosiddette funzioni ausiliarie che lo assecondano. Bénédict-Auguste Morel (1809-1873), nel suo scritto Le non-restreint, dedicato alla valorizzazione dei metodi non costrittivi usati in Inghilterra da John Conolly, lo afferma con molta chiarezza parlando del “concours indispensable que doivent offrir au médecin les auxiliaires qui le secondent”. Solo attraverso la “bonne entente” e “l’harmonie” tra i vari “employés des asiles” è possibile sottrarre gli alienati “à l’emploi des moyens coërcitifs qui les irritent et les abrutissent”.
La calma e la tranquillità degli asili inglesi, viste come conseguenze dirette del regime terapeutico non costrittivo, favoriscono l’utilizzazione dei ricoverati in compiti lavorativi, più estesa in Inghilterra che in Francia, secondo la testimonianza di Morel (e di Parchappe prima di lui): diverse le attività produttive, diversi i prodotti del lavoro meccanico, diversi i mestieri, tra cui la tipografia.
Gestire un asilo privilegiando il no restreint significa, in definitiva, rendere possibile la trasformazione del ricoverato in aliéné travailleur.
Morel elabora la sua moderata difesa del sistema di Conolly scegliendo come interlocutori privilegiati della sua argomentazione i Parchappe e i Ferrus: autorevoli alienisti, certamente, medici-direttori di importanti strutture manicomiali, ma soprattutto, lo si è detto, ispettori generali, per altro molto favorevoli ad organizzare gli asili come strutture disciplinate e produttive.
L’introduzione del lavoro nell’asilo, approvata e caldeggiata dalla maggior parte degli alienisti, diventa tuttavia ben presto un terreno di conflittualità sotterranee e di antagonismi scoperti.
Vale forse la pena, allora, ricordare molto rapidamente qualche luogo cruciale in cui viene discussa quella che solo più tardi verrà denominata ergoterapia: un modo per comprendere appieno la natura ambivalente del dispositivo asilare, a cavallo tra esclusione e inclusione, tra costrizione e coinvolgimento, tra potere come macchina coercitiva e potere come meccanismo positivo. Due volti compresenti e sinergici. Due facce della stessa medaglia.
L’ottocento psichiatrico non discute realmente attorno all’opportunità di introdurre il lavoro nel manicomio. Su tale obiettivo, come si diceva, le posizioni sono quasi totalmente unanimi, nonostante qualche differenza relativa ai modi della sua realizzazione. Discute, piuttosto, sull’equilibrio tra queste due facce. Cioè sulla natura della disciplina asilare supportata dal lavoro e sullo spazio della cura all’interno di questa stessa disciplina. I termini fondamentali della già ricordata polemica di Gauchet e Swain nei confronti di Foucault sono in realtà gli stessi che attraversavano il mondo psichiatrico del XIX secolo. Per rendere evidente questa singolare coincidenza potrà esserci forse d’aiuto qualche breve riferimento testuale, soprattutto attorno alla questione del lavoro.
Anzitutto va ricordata la posizione di Pinel, che veniva citata da tutti gli alienisti impegnati nell’utilizzazione lavorativa dei pazienti. Nel capitolo ventunesimo del Traité (1800), il “lavoro meccanico” viene considerato una “legge fondamentale” di ogni “ospizio di alienati”. Non si tratta di un “problema da risolvere”, scrive il padre della psichiatria moderna, ma di una certezza derivata dall’esperienza: “in tutti gli asili pubblici, come le prigioni e gli ospizi, il garante più sicuro, e forse l’unico, del mantenimento della salute, dei buoni costumi e dell’ordine, è la legge di un lavoro meccanico, rigorosamente eseguito”.
Esquirol rafforza questo orientamento, ricordando, nel Des maladies mentales (1838), che la parola lavoro “risuonò senza posa alle orecchie delle alienate” della Salpêtrière, diventando un motivo di interesse, una causa di eccitamento, “un’idea dominante”. Pochi mesi prima della sua morte, come si è detto, si pronuncia a favore dell’aliéné travailleur commentando l’edizione francese del Traité di Ellis.
Ma l’esperienza pratica oltrepassa queste affermazioni di principio – lo si è visto – nel momento stesso in cui, a partire dalla Ferme Sainte-Anne, vengono sperimentate, all’interno e all’esterno del perimetro asilare, le prime colonie agricole gestite da pazienti psichiatrici.
Subito dopo la morte di Esquirol, quando ormai cominciano a circolare pubblicazioni e dibattiti attorno al lavoro come forma di terapia dell’alienazione, anche la Facoltà di Medicina di Parigi lascia spazio a questo orientamento. Abbiamo così, nel 1847, la prima tesi di medicina dedicata all’argomento, scritta da Gustave-Eloi Labitte, che rivendica orgogliosamente il suo primato: finora, egli afferma, “nessuna opera compelta” su questo tema “è stata ancora scritta”.
Tutti ammettono, afferma il giovane medico, che il lavoro è utile alla terapia dell’alienazione, ma nessuno ha finora indicato quale tipo di lavoro e in relazione a quale tipo di follia. Labitte fa riferimento sia alle posizioni già ricordate dei maestri della Salpêtrière, sia a realtà asilari inglesi dove l’uso del lavoro era già stato largamente sperimentato: ad esempio da Samuel Gaskell, nel “Lancaster County Asylum”, a partire dal 1840, dove su circa cinquecento pazienti ricoverati l’80% veniva impegnato in attività lavorative. Lavoro manuale e lavoro intellettuale producono benefici effetti sullo stato mentale, sia, come aveva già detto Guislain, in quanto attività diversive, che distolgono gli alienati dai loro deliri, sia in quanto attività capaci di promuovere un rapporto con la realtà, nuovi interessi, nuove abilità, nuove conoscenze, nuove passioni.
Scrive Labitte: “l’esercizio all’aria aperta, la vista e l’odore dei campi, l’aspetto ridente della natura, il lavoro nei giardini, lo studio delle scienze per le quali ci si appassiona e che spingono all’esercizio, la botanica, l’entomologia, eccetera”. Senza addentrarci ulteriormente nelle argomentazioni di Labitte, è interessante osservare che al di là della valorizzazione del lavoro intellettuale, non certamente adatto alla gran massa dei ricoverati, sono gli incurabili, e in particolar modo gli idioti, i veri e più importanti destinatari di questa ergoterapia nascente. “Gli incurabili trovano nella disciplina e nella regolarità – cioè nei principali elementi dell’organizzazione vitale – abitudini all’ordine e al lavoro che li trasformano in operai docili e laboriosi”. Gli incurabili, e soprattutto gli idioti, possono dunque diventare ouvriers dociles et laborieux: manovrabili, disponibili, facilmente governabili. Come dire: facilmente organizzabili all’interno di una rigida disciplina lavorativa, fatta di orari precisi, di movimenti meccanici sempre eguali, di gesti ripetuti. “Devo dire che il lavoro, o piuttosto gli esercizi corporali e intellettuali, devono, nell’idiozia, produrre risultati spesso assai rilevanti”. Labitte scrive attorno ad un tema che aveva già diviso la comunità degli alienisti, fin dai tempi di Pinel.
Utilizza chiaramente, senza nominarlo, il libro di Édouard Séguin, tutto giocato sulla scommessa di una possibile educabilità degli idioti. Gli idioti sono educabili e disciplinabili, e il mio metodo, scrive Séguin, “rende i miei allievi capaci di lavorare”. Subito dopo cita, a sostegno delle sue tesi, il già ricordato passaggio pineliano, dove l’addestramento ad un lavoro meccanico viene considerato una “legge fondamentale” dell’asilo. Dopo essersi dedicato per più di dieci anni, con Itard, all’educazione di Victor, il famoso «enfant sauvage » dell’Aveyron, Séguin viene incaricato di organizzare a Bicêtre, nel 1840, l’istruzione dei bambini idioti. L’idiota è educabile, non tramite sollecitazioni esterne, come voleva Itard, ma rivolgendosi a “l’homme intérieur”. La radicalità delle sue posizioni, il fatto di non essere medico e il suo impegno attivo nella rivoluzione del 1848 lo tagliano fuori dal gioco istituzionale. Viene perciò clamorosamente espulso da Bicêtre, a vantaggio del suo nemico giurato, l’alienista Félix Voisin. Emigra negli Stati Uniti, dove trova spazio – politico e scientifico – per la sua battaglia ottenendo, nel 1861, il titolo di dottore in medicina.
Riprendendo alla lettera l’enunciazione di Séguin sopra ricordata, potremmo dire che la disciplina lavorativa dell’asilo non costruisce la persona dell’aliéné travailleur, ma la sua forza-lavoro. Non insegna il lavoro, o uno specifico lavoro, ma forgia l’attitudine al lavoro, la potenzialità lavorativa che appartiene a tutti: agli individui “abili” e a quelli “non abili”.
Anche Marx, nel Primo Libro del Capitale, parla di “operai abili” e di “operai senza abilità”, “non abili”, mostrando la presenza necessaria di questi ultimi entro la logica della manifattura capitalistica, portata a disfarsi dell’abilità artigiana, troppo spesso foriera di intelligenza e di capacità antagonista. Rinviando a Ferguson, egli afferma che “le manifatture prosperano di più dove meno si consulta la mente, di modo che l’officina può essere considerata come una macchina le cui parti sono uomini”. Subito dopo ricorda come già attorno alla metà del settecento “alcune manifatture adopravano di preferenza per certe operazioni semplici, che però costituivano segreti di fabbrica, proprio dei semiidioti”. Infine, citando Adam Smith, scrive: “l’uomo che spende tutta la vita eseguendo poche operazioni semplici…non ha nessuna occasione di esercitare il suo intelletto…Generalmente, diventa stupido e ignorante quanto è possibile a creatura umana”. Come ricorda Marx, Smith ha messo in evidenza “l’ottusità dell’operaio parziale”, affermando che “l’uniformità della sua vita stazionaria corrompe naturalmente anche il coraggio della sua mente”. In ultima analisi, commenta ancora Marx, “la suddivisione del lavoro”, quando diventa la “forma consapevole del modo di produzione capitalistico”, si svela come “l’assassinio d’un popolo” (D. Urquhart): produce “rattrappimento intellettuale e fisico”, rivelando così il suo volto spietato e liberticida.
L’uomo ridotto a macchina. Parcellizzato. Disciplinato e docile. L’ergoterapia nascente privilegia, in questa prospettiva, pazienti “non abili”. Idioti, imbecilli e incurabili sono educabili attraverso l’azione congiunta di esercizi rivolti al “sistema muscolare” e di sollecitazioni capaci di sfruttare il principio dell’imitazione (i pazienti “non abili” imitano facilmente i convalescenti, normalmente in grado di svolgere attività lavorative e di sottostare alla disciplina). E l’imitazione, come scrive efficacemente Séguin, è “l’ultima parola dell’azione muscolare”.
Al di là delle intenzioni del suo autore, la thèse di Labitte, lettore di Séguin, ha senza dubbio il merito di rendere comprensibile la logica di espropriazione e di frammentazione che presiede allo sfruttamento degli aliénés travailleurs, impegnati, come aveva preconizzato Pinel, in un “travail mécanique”: il lavoro deve infatti implicare “un’occupazione regolare, ad ora fissa, forse una vita claustrale che, forzando il malato all’ordine fisico, sia in grado di indirizzarlo verso l’ordine morale”. Agli idioti servono esercizi predisposti entro un ordine logico, “con gradazione”, passando dal non conosciuto al conosciuto, dal “semplice” al “complesso”.
Questo processo di addestramento della forza-lavoro manicomiale viene tuttavia presentato dallo stesso Labitte – nella già ricordata memoria dedicata alla colonia agricola di Fitz-James – come un’alternativa ad ogni idea di sequestro degli alienati e ad ogni pratica di costrizione. Nell’asilo, la disciplina lavorativa, contrapposta alla séquestration e alla contrainte, viene direttamente collegata dall’autore al modello inglese del no-restreint realizzato da Conolly, svelando così il suo duplice volto: repressivo – poiché si tratta, come è stato detto, di forzare il malato all’ordine fisico – ma anche costruttivo e propositivo, poiché si tratta di rieducare il paziente alla percezione del proprio corpo, del tempo e dello spazio. Tramite il lavoro, la mente “malata” – anche se dentro la tirannia dei regolamenti, anche se dentro le regole forzosamente imposte dall’istituzione – si riavvicina al mondo, alla relazione con se stessa e con gli altri. Entro il perimetro dell’istituzione segregante, il potere disciplinare veicolato dal lavoro allestisce una sorta di teatro della duplicità e dell’ambivalenza: presiede, in altre parole, alla messa in scena di un doppio vincolo generalizzato e ineludibile, dove aspetti impositivi e coercitivi coabitano con aspetti propositivi e formativi.
Si spiega così come il più accanito paladino dell’ergonomia nascente – il già citato alienista Pierre-Hippolyte Belloc, spesso smentito e censurato dall’establishment della psichiatria francese – abbia difeso e propagandato il sistema delle colonie agricole, denunciando, al tempo stesso, “il sistema di accasermamento di massa” dominante negli asili, che finisce per instaurare “una sorta di prolungamento delle catene dei tempi andati”: un sistema che produce “l’amministrazione meccanica” (l’administration à la mécanique) dei ricoverati e il loro conseguente “trattamento meccanico” (traitement à la mécanique), che “immobilizza per sempre” gli asili, rendendo impossibile “una vera riforma”, una riforma progressiva, “indefinitamente progressiva”. Se riusciremo a realizzarla, scrive con tono ispirato Belloc, “avremo finalmente preparato, per l’avvenire, a vantaggio della più gran parte degli alienati, un regime di dignità, di libertà, di vita comune, di affetti di famiglia, di benessere, di sviluppo fisico e morale”, insperabile, oggi, se ci si attiene alla “teoria dell’irresponsabilità e alle sue forme obbligate di applicazione”. Nello scritto dell’anno successivo, Belloc renderà ancora più esplicita questa singolare combinazione tra polemica antiautoritaria e difesa ad oltranza della colonia agricola. La fattoria-asilo, per Belloc, rappresenta una via di mezzo tra un’impossibile libertà assoluta degli alienati ed il loro inaccettabile “sequestro asilare”. Addestrare i pazienti al lavoro significa educarli all’ “ordine”, al “metodo”, e soprattutto all’ “economia del tempo”, a tutto vantaggio dei livelli di produttività delle colonie agricole. Gli alienati, infatti, sono “in generale più docili e più facili da gestire rispetto a dei normali operai”. Nel momento stesso in cui l’asilo si trasforma in un “centre d’exploitation rurale”, ci si accorge subito che “tutte le categorie e le sotto-categorie di cui si parla non sono mai esistite al di fuori dei libri; da nessuna parte, da nessuna parte, fortunatamente per i poveri alienati, esse sono state messe seriamente in pratica”.
Questo l’affondo polemico decisivo, che colloca Belloc, definitivamente, ai margini dell’ortodossia psichiatrica dominante. L’ispettore Parchappe esprime con molta chiarezza, fuori da ogni tentazione riformista e da ogni anelito libertario, l’assetto più stabile di tale ortodossia. Vale forse la pena allora, per comprendere appieno le dimensioni contraddittorie del potere disciplinare dentro gli asili, restituirgli per l’ultima volta la parola:
“L’ordre et la régularité dans tous les actes de la vie commune et privée, la répression immédiate et incessante des fautes de toute espèce, et du désordre sous toutes ses formes, l’assujettissement au silence et au repos pendant certains temps déterminés, l’imposition du travail à tous les individus qui en sont capables, la communauté des repas, les récréations à heure fixe et à durée déterminée, l’interdiction des jeux qui excitent les passions et entretiennent la paresse, et par dessus tout l’action du médecin imposant la soumission, l’affection et le respect par son intervention incessante dans tout ce qui touche la vie morale des aliénés: tels sont les moyens de traitement moral qui ne peuvent être employés que dans les maisons spéciales, destinées au traitement de la folie, qui donnent au traitement appliqué dans ces maisons une supériorité incontestable relativement au traitement appliqué à domicile”.
Disciplina, lavoro, autorità, trattamento morale di massa: questo, in definitiva, l’orizzonte asilare della cura.
6. Cura, malattia e antagonismo
Una specifica e complessa relazione, modificabile nel tempo e nello spazio, tra valenze curative e valenze disciplinari della terapia deve quindi essere compresa come tratto distintivo della psichiatria clinica, considerata durante l’intero arco della sua storia. Senza mai negare, sottovalutare o sopravvalutare un solo termine di questa relazione.
Riferita all’attualità, l’enfasi sull’approccio empatico-curativo rischia di trasformarsi in una vuota e fuorviante retorica se non si accompagna ad una valutazione critica della misura in cui la qualità e la possibilità stessa di questo approccio vengono influenzate almeno da due fattori: le caratteristiche del contenitore istituzionale e l’azione sedante del farmaco. Un farmaco che può anche funzionare come “assolutore simbolico della relazione” (Fausto Petrella) o addirittura come nuova camicia di forza chimica, capace sia di rendere inutile la segregazione e la contenzione sia di ottundere o di modificare i sintomi, sia – caso non infrequente – di produrre nuovi sintomi specifici, somatici e psichici.
Alla cancellazione o alla sottovalutazione, sul terreno dell’analisi storica, delle valenze disciplinari e dispotiche del trattamento morale, corrisponderebbe così, sul terreno clinico, l’attuale cancellazione o sottovalutazione delle valenze coercitive e sedative dell’intervento chimico: con il risultato di far emergere una sorta di falsa coscienza dell’operatore e quindi una conseguente e pericolosa divaricazione tra le sue teorie espresse e le sue pratiche taciute. In questo caso, ieri come oggi, le tecniche dell’assoggettamento verrebbero contrabbandate per tecniche della cura.
Analogamente, alla cancellazione o alla sottovalutazione delle valenze dialogiche e curative del trattamento morale, corrisponderebbe l’attuale cancellazione o sottovalutazione, sul terreno clinico, delle possibilità di una efficace presa in carico dei pazienti che valorizzi gli orizzonti della relazione. Ed in questo caso, ieri come oggi, le modalità della cura e della presa in carico – cioè le possibilità effettive di migliorare la qualità di vita e la condizione di salute del paziente – verrebbero ideologicamente negate o appiattite sulla dimensione del controllo, dell’esclusione, della relazione di potere.
L’opzione storiografica, qui come in altri settori, non è mai neutra: le interpretazioni della rottura pineliana hanno più volte espresso, non v’è dubbio, orientamenti di carattere teorico, politico, ideologico.
Il rapporto terapeutico, nella prima alienistica, cioè nei primissimi anni dell’ottocento – almeno, come si diceva, dal 1800 al 1809 – pur svolgendosi entro una cornice disciplinare, pur realizzando, senza ombra di dubbio, una relazione totalmente asimmetrica che produce l’assoggettamento del paziente al suo medico, mantiene comunque, tra le due figure, un gioco dialettico: un gioco di scambi e di interazioni, di conflitti e di mediazioni. Lo scenario alla Mason Cox, spesso reiterato nel testo pineliano, non rappresenta ancora l’imposizione della realtà al delirio, e quindi la conseguente capacità, lo si è già detto, di contrastare il delirio, di lottare contro la sua forza, di togliergli, quindi, il potere di sottrarsi al reale.
Nell’ambito della protopsichiatria, l’alienista deve essere in grado di mettersi in armonia, per l’appunto, come diceva Esquirol, con il delirio del suo paziente, con le idee-madri, con i nuclei generativi che lo producono: fino al punto da introdurre nel cosiddetto reale una torsione, una forzatura, capace di rendere questo stesso reale omogeneo al delirio. L’alienista, in questa prospettiva, simula, usa l’arte della simulazione: mette in scena finti processi, finte istanze giudiziarie, adeguando il mondo esterno al mondo interno del folle: al fine, ovviamente, di eliminare dalla mente del malato le idee deliranti, le false credenze, le concezioni che hanno prodotto in lui malessere e sofferenza. Per cambiare l’immagine del mondo che produce il dolore, come direbbe Watzlawick, il sintomo non viene negato, represso, delegittimato, trattato come motivo di colpa e di vergogna. Esso, semmai, viene blandito, assecondato, in una certa misura rinforzato e legittimato, anche se con la dichiarata finalità di permettere al paziente di riconoscerlo ed eventualmente di superarlo. Riconoscerlo, dunque, non negarlo, non delegittimarlo, non sopprimerlo.
Alle simulazioni utilizzate dall’alienista corrispondono spesso le simulazioni prodotte dal paziente. Vi è una frase decisiva di Pinel, che condensa con rara efficacia la presenza di queste posizioni incrociate, la cui posta in gioco, dal punto di vista medico, è l’affermazione della verità: il trionfo definitivo della ratio, l’uscita liberatoria dai labirinti della simulazione. Egli afferma infatti, nella prima edizione del suo Traité: “Je parle des maladies simulées sur un grand théâtre et au centre même des lumiéres”. Parlo delle malattie simulate – scrive dunque Pinel, non menzionando, qui, le simulazioni prodotte dal medico – su un grande teatro e nel cuore stesso dei lumi.
La posta in gioco dell’affrontamento è la vittoria della ragione. Il microcosmo asilare diventa così, per Pinel, un grande teatro, collocato nel cuore stesso dei lumi, dove la lotta contro l’opacità dei comportamenti devianti e contro la simulazione acquista un elevato valore simbolico.
Collocare il paziente in un gran teatro e renderlo protagonista (o, quantomeno, deuteragonista) di una dialettica tra verità ed errore, significa anche individuare nel paziente stesso almeno due registri fondamentali che scandiscono la sua presenza:
1. Un mondo interno, una interiorità, che occorre comprendere, decifrandone i “segreti”. Occorre, affermava il grande medico-filosofo riferendosi ai pazienti, penetrare “il segreto dei loro pensieri”.
2. Una capacità di resistere ai dispositivi disciplinari: al potere del medico ed alla forza degli apparati teorico-pratici che lo supportano.
Le pagine che Le pouvoir psychiatrique dedica a questo secondo punto sono particolarmente efficaci e suggestive. Si è verificata, afferma Foucault, una “grande insurrezione simulatrice” (PPF, 137), che ha avuto il suo epicentro nel manicomio femminile della Salpêtriére: dall’epoca dei Pinel e degli Esquirol fino all’epoca di Charcot e delle sue celebri pazienti isteriche: grandi simulatrici oltre che prodigiose interpreti di un gioco teatrale. “Si è trattato, dice Foucault, di un fenomeno di lotta, e non di un fenomeno patologico” (PPF, 136). L’isteria e la simulazione rappresentano il “rovescio militante del potere psichiatrico” (PPF,138). Ed ancora: “Se si ammette che la simulazione è stata la modalità insidiosa per mezzo della quale i folli hanno posto di forza la questione della verità a un potere psichiatrico che voleva imporre loro nient’altro che la realtà, allora credo che sarà possibile fare una storia della psichiatria che non graviterà più attorno allo psichiatra e al suo sapere, bensì, finalmente, attorno ai folli” (PPF, 138).
La distinzione così netta, così tranchante, tra fenomeno di lotta e fenomeno patologico solleva complesse e spinose questioni di carattere epistemologico e politico, che forse varrebbe la pena affrontare separatamente. Mi limito, qui, a qualche rapida osservazione. Pur rimanendo una condizione morbosa, pur rimanendo uno stato di sofferenza psichica, un disagio, un dolore, una lacerazione, la patologia mentale, prodotta anche dal sapere/potere dei medici – come lo stesso Foucault ha più volte ribadito, assieme ad altri prima e dopo di lui (si pensi a Ivan Ilich e a Edward Shorter, per non citare che loro) – può rappresentare al tempo stesso un momento di resistenza, di insurrezione attiva contro il conformismo, contro la violenza, più o meno esplicita, delle norme e delle istituzioni. Come dire: fenomeno di lotta, di resistenza, di rivolta e fenomeno patologico non sono necessariamente due dimensioni incompatibili.
Sta a testimoniarlo, fra tanti altri esempi possibili, la scrittura vertiginosa di Antonin Artaud, grande schizofrenico, “écrivain insurgé” (come egli stesso si definiva), molto amato dallo stesso Foucault.
Stanno a testimoniarlo altre figure celebri di pazienti schizofrenici creativi, che hanno espresso una forte carica di antagonismo e di rivolta. Accanto ad essi, quello che potremmo chiamare il popolo minuto della schizofrenia, con le sue rotture, i suoi deliri, le sue lacerazioni.
Accanto ad essi, tante altre figure della patologia psichiatrica, soprattutto della patologia malinconica: cioè della patologia che ha espresso ed esprime, congiuntamente, un elevatissimo numero di soggetti comuni (il popolo dei depressi) ed un significativo numero di “atrabiliari” illustri: andres perittoi, uomini eccellenti, come li definiva un testo greco tardo antico di scuola aristotelica: artisti, filosofi, poeti, uomini di governo.
In età moderna, malinconiche, non lo si dimentichi, vennero definite le streghe. Così le classificava e le medicalizzava la medicina mentis prepsichiatrica, tra il rinascimento e l’età dei lumi: una medicina coeva ai tribunali dell’inquisizione, prima affiancata al sapere demonologico, poi, progressivamente, antagonista rispetto ai suoi assunti ed alle sue procedure (la tortura, la confessione, il rogo). Le streghe “malinconiche”, lo si sa, rappresentano un momento di resistenza e di ribellione contro i poteri congiunti della morale, della religione e della medicina: un momento che si sviluppa parallelamente alla nascita e all’affermarsi del razionalismo e della scienza durante tutta l’età moderna.
Posta in gioco essenziale di questo processo di “medicalizzazione”: la repressione, la canalizzazione e il controllo di un fenomeno collettivo, di massa, che esprime dissenso, rifiuto, antagonismo femminile diffuso. A questo rifiuto massificato, assolutamente anarchico e privo di progetto politico, la medicina assegna un principio di individuazione: la malinconia. Malinconia, certo, è un nome, un luogo definito entro la millenaria topografia della verità medica: ma la designazione nosografica e il suo oggetto, qui, si fronteggiano; non rappresentano ancora, rispettivamente, il contenente ed il contenuto. Perché questo avvenga – e perché la medicalizzazione si imponga definitivamente – la repressione inquisitoriale deve fare il suo corso: deve accusare, torturare, bruciare. Solo a partire dalle fondamenta rimosse di questo cupo scenario di morte il sapere positivo potrà affermarsi: il delirio della strega potrà confluire in un capitolo della patologia mentale; il soggetto sociale massificato potrà esistere unicamente come individuo, sottratto alla comunità, ridotto a disperata solitudine, definito e confinato entro gli spazi angusti di un unico sapere. Ma la maturazione definitiva di tale passaggio è resa possibile da un affrontamento, da un corpo a corpo tra le categorie della medicina e la straordinaria potenza di un soggetto irriducibile e nemico: un soggetto destinato a soccombere, sotto il peso congiunto della tortura e della terapia, che producono, rispettivamente, la capitolazione e il consenso. E’ vero: un soggetto sociale soccombe, viene sconfitto, prima dalla repressione inquisitoriale, poi dall’azione medica. Dominazione e violenza fisica creano un terreno favorevole all’assoggettamento, alla persuasione, alla “terapia”. Il malinconico, in quanto soggetto malato, prende il posto dell’eretico, del peccatore, del ribelle. Questo vale per la strega e varrà anche, alla stessa maniera – in epoca successiva e in un diverso scenario –, per il folle. Come scrive Foucault riferendosi al paziente internato nell’asilo ottocentesco, “si tratta di dominare o di vincere” una potenza estranea, nemica, irriducibile: occorre dominare e vincere, attraverso un reticolato disciplinare, attraverso un insieme coerente e finalizzato di regole, qualcosa che si presenta come “una forza”, come “un pericolo”, come “un potere minaccioso”
Tornando allo scenario asilare ottocentesco, ritroviamo “pazienti” che sono, al tempo stesso, individui anomali, sofferenti, “malati” e soggetti antagonisti (isterici, malinconici, schizofrenici, eccetera): messi in campo, pro-dotti dal sapere/potere della psichiatria in quanto pazienti da assoggettare, essi fanno emergere, dentro la loro appartenenza antagonista al potere disciplinare, qualcosa come un mondo interiore: un mondo sovente opaco, segreto, enigmatico, mascherato dai giochi della simulazione, ma in ogni caso un mondo interno, al quale il sapere del medico deve riconoscere una relativa autonomia: tema, questo, che l’ultimo Foucault svilupperà con formidabile originalità e profondità (in testi come L’ermeneutica del soggetto, L’uso dei piaceri, La cura di sé).
Il sapere panottico del medico, che punta a produrre l’assoluta trasparenza e la totale docilità del soggetto internato, deve accettare che questo stesso soggetto, capace di esprimere resistenza e conflitto, non sia sempre interamente visibile e controllabile. Ai margini della disciplina emerge sempre ciò che Foucault chiama lo scarto, l’irriducibile, l’inclassificabile: una zona d’ombra, un’area opaca, una ricchezza segreta. Di più: uno spazio “interno”, impenetrabile e incomprensibile se si rimane confinati entro gli spazi angusti di una disciplina.
Da questa dimensione enigmatica dell’irriducibile – vorrei aggiungere – emergono effetti di realtà, agìti individuali e sociali, sofferenze, sprofondamenti, eccitamenti: dimensioni che il sapere-potere del medico cerca in tutti i modi di decifrare, di nominare, di classificare, costruendo una nosografia che si modifica nel tempo.
Strana davvero questa dialettica, che collega strettamente i comportamenti “patologici” e la loro trascrizione nosografica. Questi comportamenti spesso sfuggenti, individualmente variabili, modificabili nel tempo e nello spazio, costringono il lavorìo della trascrizione a un perenne movimento di recupero e di concettualizzazione. L’antagonismo dei soggetti si manifesta anche in questa loro continua sottrazione, in questa loro continua fuga, che alimenta perennemente, nel sapere-potere psichiatrico, il gioco della rincorsa e della ridefinizione.
“E sarà un gioco – una specie di perpetuo reciproco inseguirsi, con i malati che non cessano di tendere trappole al sapere medico in nome di una determinata verità e all’interno di un certo gioco di menzogne, e con i medici che cercano continuamente di riprendersi i malati con la trappola di un sapere neurologico relativo ai segni patologici, ovvero di un sapere medico serio – che attraverserà come una lotta reale tra medici e malati tutta quanta la storia della psichiatria del XIX secolo” [PPI, p. 181].
Non a caso, vale la pena ribadirlo, la nosografia psichiatrica – anche se spesso con lentezza, anche se spesso all’interno di continuità plurisecolari – si trasforma, si modifica nel tempo e nello spazio: varia con il variare dei soggetti, dei contesti familiari, sociali, culturali. Trasformazioni della nosografia e conseguenti riassetti del sapere psichiatrico rappresentano una formidabile ed eloquente testimonianza della potenza produttiva di quello che abbiamo appena definito il gioco della rincorsa e della ridefinizione.
Il lavoro di Foucault ci insegna a comprendere la dinamica di queste trasformazioni: comprenderla significa anche mettere a fuoco lo spessore storico-antropologico delle categorie nosografiche utilizzate in psichiatria: i loro confini instabili, la loro necessaria plasticità.
Storia ed epistemologia della psichiatria – di una psichiatria tramata da resistenze, da opacità, da antagonismi, da simulazioni e da dissimulazioni – rivelano qui una fisionomia radicalmente distante da ogni acribia disciplinare, da ogni rassicurante schema lineare ed evolutivo. Le categorie, dietro ogni loro fragile e provvisorio scheletro concettuale, grondano sangue, conflitti, lacerazioni, euforie, inabissamenti. Si tratta allora, come scriveva Marx nella Miseria della filosofia, di restituire le categorie alla loro “storia profana”. Si tratta, voglio ripeterlo, di sottolineare il loro spessore storico ed antropologico: la loro apertura verticale anche verso le dimensioni precategoriali e non discorsive della nostra presenza.
Occorre comprendere e vivere tale apertura: ci sembra, questa, una delle più importanti ricadute dell’itinerario genealogico sul terreno del lavoro clinico e della pratica filosofica. Più in particolare, sul terreno di un ripensamento storico-critico del sapere psichiatrico.
La scatola di arnesi del “genealogista” richiede oggi, più che esegeti e commentatori, l’individuazione di campi d’applicazione, di territori – e perciò di saperi e di pratiche – entro i quali sia possibile verificarne la fertilità e l’applicabilità. E’ ciò che si augurava, del resto, lo stesso Foucault, che non ha mai amato, come è noto, la dimensione dell’esegesi e del commento.
La ricerca “genealogica” di Michel Foucault – la sua boîte à outils, come egli amava definirla – può essere proficuamente utilizzata anche da clinici, da operatori sociali, da soggetti radicati in un campo di pratiche. A questo livello, più che attraverso le maratone accademiche dell’esegeta o del commentatore, essa può ancora rivelarci la sua potenza euristica.
Per esprimere sinteticamente la direzione del nostro “uso” delle straordinarie lezioni dedicate al potere psichiatrico – dalle quali siamo partiti – voglio ricordare ciò che affermava Foucault, nel 1975, a proposito del suo “uso” di Nietzsche:
La seule marque de reconnaissance qu’on puisse témoigner à une pensée (…), c’est précisement de l’utiliser, de la déformer, de la faire grincer, crier. Alors, que les commentateurs disent si l’on est ou non fidèle, cela n’a aucun intérêt.
galzigna@unive.it
(Università di Venezia)
