Parrebbe sensato inaugurare uno scritto dedicato al tema del suicidio qualificando quest’ultimo come un atto folle e insensato, dettato dalla disperazione o da una radicale perdita di lucidità. Tuttavia, così non sarà. Ho dedicato gli ultimi mesi ad approfondire il tema della “libera morte” – ad analizzarne gli aspetti psicologici, sociali, narrativi e filosofici – e tutto quel che ho incontrato è stato, a dire il vero, un abisso di intensa, drammatica lucidità: un arcipelago di riflessioni dolorose, ma mai prive di logica o di senso.
Mi concentrerò, in questa sede, su un’opera in particolare: un breve saggio intitolato Note sul suicidio (Notes on suicide, 2015, Fitzcarraldo; Carbonio, 2022, traduzione di Alberto Cristofori), a opera del filosofo britannico Simon Critchley. Non trascurerò, tuttavia, alcune rapide digressioni e divagazioni, riguardanti scritti di simile impostazione o a esso affini.
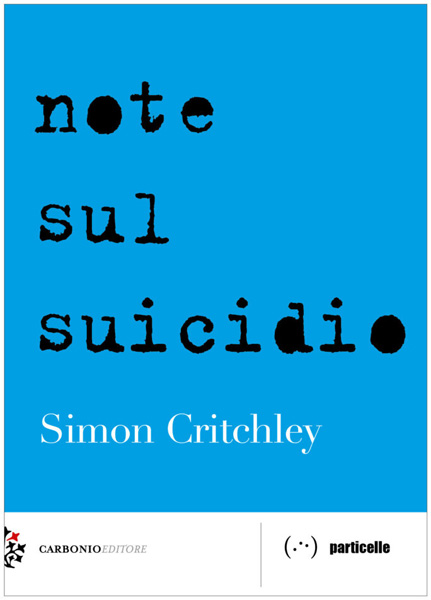
È innanzitutto importante notare come le considerazioni stilate da Critchley – come rivela egli stesso nel primo capitolo del libro – procedano non da ricerche di tipo accademico, ma dall’esperienza personale. L’esperienza di una vita andata «in frantumi»; il rovescio catastrofico di un’esistenza di colpo tormentata da «pensieri suicidi e “tendenze suicide”». Ciò comporta che la prospettiva dell’autore sul tema sia non solo “informata sui fatti”, ma più direttamente interessata alle implicazioni di ogni singola frase riportata nel testo. Un evento – stando, almeno, all’algido distacco coltivato dall’accademia – piuttosto raro e insolito.
Critchley, tuttavia, non offre al lettore una sorta di confessione, né un’auto-fiction (come si suol dire) innervata di teoria. Si tratta, al contrario, di una delle sopra menzionate “prospettive lucide”: uno strumento per osservare più da vicino, e con più attenzione, il fenomeno del suicidio.
L’autore prende le mosse da uno scritto dell’empirista inglese David Hume, Del suicidio, pubblicato postumo nel 1777. Il saggio è presente in appendice al libro di Critchley sia nell’edizione inglese, sia in quella italiana. Per Hume, l’atto di togliersi la vita è lecito, se non addirittura dovuto, in tutti quei casi nei quali le sofferenze superino le gioie, in quelli nei quali si è divenuti un peso per sé stessi e gli altri o, ancora, in quelle – rarissime – occasioni nelle quali dalla nostra vita dipende il benessere o la salvezza dell’intera collettività. Per giustificare tale conclusione e riassumere le sue varie argomentazioni sul tema, Hume scrive: «Un uomo che si ritira dalla vita non fa alcun male alla società. Smette semplicemente di fare del bene; il che, se è un’offesa, è delle meno gravi» (p. 148). In gioco, sia per Hume, sia per Critchley, vi è l’idea che il suicidio – come anticipato nelle prime righe di questo scritto – sia in qualche modo un’offesa, un’aberrazione o una deviazione dal “naturale” flusso delle cose. Un’idea che la nostra società, la nostra cultura e noi stessi, in prima persona, abbiamo contribuito ad alimentare.
Il secondo capitolo del libro si occupa di stilare una breve storia delle tesi a favore del suicidio – controbilanciate dagli argomenti filosofici e popolari (si potrebbe dire folk, nel senso di “ingenui”) più noti e diffusi. Tra le contro-argomentazioni alle liceità del suicidio, come nota Critchley sulla scorta di Hume, la più comune è quella incentrata sulla “sacralità” della vita, o sull’idea che quest’ultima sia un “dono” – di Dio o dei propri genitori. Un argomento che può essere affrontato da diversi punti di vista, ad esempio replicando che se la vita è un dono – come lo sono un cappello di lana o una penna stilografica ricevuti per Natale – allora sono libero di farne quel che mi pare, persino “sbarazzarmene”. Se, d’altra parte, la vita e l’esistenza cosciente sono davvero qualcosa che Dio o i miei genitori mi hanno “donato”, essi sono pur sempre doni non richiesti (come qualsiasi altro dono); non ho scelto di venire al mondo, così come non ho scelto di patire le sofferenze che, ora, in questo preciso istante, mi spingono a valutare l’ipotesi del suicidio. A chi obietta che Dio ha sempre un piano per noi, o che il suicidio è contro-natura, dal momento che solo Dio ha il potere di decidere quando e dove moriremo, si potrebbe sempre rispondere, come nota Critchley, che «allora ogni forma di malattia e di ferita non dovrebbe essere curata, perché ciò va contro le leggi della natura e la volontà di Dio» (p. 50). Oppure – nei casi più ostinati – che solo un Dio «malevolo e cattivo» potrebbe desiderare che «io patisca un dolore insopportabile e senza fine» (p. 51).
La fragilità e scarsissima complessità delle obiezioni alla liceità del suicidio – e, di conseguenza, anche dell’eutanasia – rivelano come quest’ultimo sia ancora un argomento largamente tabù, persino nella società del boom tecnologico e del libero mercato. Dal momento che questo non è il luogo più adatto a un’esposizione dettagliata di tale problema, mi limiterò a notare come l’esistenza stessa di queste contro-argomentazioni, nonché il fatto che qualcuno (in realtà molti) se ne riempia la bocca, costituisce una dimostrazione pratica del funzionamento di tutta una serie di meccanismi di repressione biologici, psicologici, culturali, economici e sociali. Dispositivi di controllo e disciplinamento anche non direttamente correlati ai temi del suicidio o del “fine vita”.
Nel suo Every Cradle is a Grave. Rethinking the Ethics of Birth and Suicide (Nine-banded Books, 2014), la filosofa analitica Sarah Perry segue un percorso leggermente differente rispetto a quello tracciato da Critchley. Il primo capitolo del libro di Perry, infatti, è dedicato a un altro contro-argomento molto diffuso, riassumibile attraverso la domanda: “Se è meglio non essere mai nati, allora perché la gente non si suicida?”. La più coerente prosecuzione di tale domanda, del tutto retorica, consiste nel far notare come il suicidio sia un “bene” ampiamente disponibile e del tutto “gratuito”: basta procurarsi del veleno, o salire all’ultimo piano di un palazzo. Nel suo libro, Perry mostra in che modo tale supposizione sia del tutto errata.
Gli elementi che gravitano attorno all’ideazione suicida e al desiderio di togliersi la vita sono di gran lunga più numerosi di quanto si pensi in genere: si va dalla naturale avversione fisica al dolore, al pensiero dei propri cari; dallo stigma sociale nei confronti del suicidio, all’inefficacia dei metodi di suicidio più noti e diffusi. L’idea che il suicidio sia un “bene gratuito” e “disponibile a tutti” dipende, a sua volta, dal fatto che il suicidio non è legalmente perseguito: nessuno può essere ritenuto “colpevole” di aver tentato di togliersi la vita. Per Perry, tuttavia, anche quest’ultimo punto di vista è del tutto ingenuo, se non addirittura fondato su una radicale malafede. Se scoperto, di fatto, il tentato suicida viene trasportato in ospedale – dove sarà rianimato o curato contro la sua stessa volontà; verrà poi chiuso in una stanza con le sbarre alle finestre, e sorvegliato h24 da infermieri e telecamere; non gli sarà concesso introdurre nella propria stanza determinati oggetti, quali lacci e coltelli. La vita che si dischiude in seguito a un fallito suicidio è una vita di prigionia, nel corso della quale la “vittima” verrà formalmente ritenuta instabile o squilibrata per tutto il tempo a venire.
La tesi di Perry, in fondo è la stessa di chi da un secolo parla di “biopolitica” e “necropolitica”: la vita umana, in ogni suo aspetto – e, forse, ancor più nel suo tentativo di assumere il controllo sul proprio destino finale – è oggetto di rapporti di potere e norme socioculturali.
L’idea popolare, madre delle debolissime tesi che reputano la vita un “dono” e la morte un “bene gratuito” – tesi avvalorate da secoli di elucubrazioni filosofiche, teologiche, letterarie e giudiziarie – nasconde, al suo interno, una ben più amara verità. Il suicidio, come scrive Critchley, è un gesto di «usurpazione della sovranità, un atto di insubordinazione moralmente imbarazzante e reprensibile» (p. 54).
Nella seconda parte di Note sul suicidio, Critchley prende in esame i messaggi di addio dei suicidi. L’autore stesso, come racconta all’inizio del terzo capitolo, ha organizzato nel 2013 un breve laboratorio di scrittura denominato La scuola della morte – in ironica antitesi a un ben noto progetto di self-help: La scuola della vita. La scuola della morte si è occupata di analizzare un gran numero di messaggi di addio, con l’obiettivo di far stilare ai partecipanti un loro ipotetico, ultimo messaggio. Un’iniziativa che ha condotto Critchley a prendere atto di un altro aspetto riguardante l’atto del togliersi la vita. Spesso, nei biglietti di addio dei suicidi si palesa un contraddittorio e paradossale intreccio di narcisismo e odio nei confronti di sé; di egoismo e protesta; di amore, rancore e dispiacere nei confronti dei propri cari. Ulteriore testimonianza della complessità esistenziale, psicologica e sociale del suicidio.
Nell’ultimo capitolo del libro, attraverso la disamina delle opere di Woolf, Camus, Amery, Cioran e Levé, tale complessità giunge al punto di collasso, rivelandosi per quel che davvero è: un vortice esistenziale, legato non tanto alla morte, quanto alla vita e all’esistenza umana cosciente. È proprio Cioran – il pessimista, per così dire, definitivo del ’900 – a suggerire a Critchley che il suicida non è un pessimista, ma un ottimista radicale: qualcuno che ritiene che la vita, in qualche modo, in qualsiasi modo, avrebbe potuto serbare qualcosa di meglio per lui.
Adottando una visione del mondo più pessimistica e disincantata, meno avvezza ad attendersi qualcosa dalla vita, afferma Critchley, l’individuo può infine avvedersi dei «piccoli miracoli quotidiani». Come scrive Critchley:
«Quando la vita si arresta e noi abbiamo di fronte l’infinito mare in movimento, indifferente e grigiastro, quando ci manteniamo aperti con tenerezza a quell’indifferenza, senza desiderare, commiserarci, lamentarci o aspettare una ricompensa o un premio scintillante, allora potremmo essere diventati, per un attimo, qualcosa che è durato e che durerà, qualcuno che può trovare una sorta di autosufficienza: qui e ora» (p. 128).
È a questo punto, nelle ultimissime pagine, che l’argomentazione di Critchley si fa contorta e insufficiente, avviluppandosi su se stessa. L’apologia della libera morte si affloscia come un sacco vuoto, venendo alla bell’e meglio rattoppata per mezzo di un grosso cerotto etico, dal retrogusto tragico e persino eroico. Critchley abdica l’“abbondanza negativa” offerta da pensatori contemporanei quali David Benatar, Ray Brassier, Thomas Ligotti, Eugene Thacker e Sarah Perry, scegliendo di tornare – sul più bello – a più miti consigli.
Il lettore “più realista del re” non potrà fare a meno di vedere all’opera, in tale improvvisa marcia indietro, gli stessi meccanismi di difesa elencati nel primo capitolo. Impossibile, tuttavia, trattenere un moto di empatia e tenerezza nei confronti dell’autore. Impossibile non fraternizzare con chi ha visto la propria vita «andare in frantumi», e che ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per salvare qualche misero coccio dalla scopa e dalla paletta dell’indifferenza cosmica. Gli stessi termini impiegati da Critchley, quali «desiderare», «commiserarci» e «lamentarci», rivelano una ruvidezza del tutto inattesa. La ruvidezza che, d’altronde, ci si aspetterebbe da un “sopravvissuto” che è riuscito a far ritorno al normale corso delle cose quotidiane.
Vale la pena concludere con una citazione tratta da una delle opere che informano il breve libro di Critchley. Si tratta di Levar la mano su di sé. Discorso sulla libera morte (Hand an sich legen. Diskurs über den freitod, 1976), del filosofo francese (ed ex internato del campo di concentramento di Auschwitz) Jean Amery. Scrive Amery:
«Anche quando si avvicina alla soglia del salto, l’aspirante suicida deve mostrarsi all’altezza delle arroganze della vita, altrimenti non troverebbe il cammino verso la libertà e sarebbe come il prigioniero di un campo di concentramento che non osa gettarsi sul filo spinato, che vuole ancora ingurgitare la zuppa della sera e poi, al mattino, la sbobba di ghiande, e a mezzogiorno di nuovo una zuppa di rape, e così di continuo. Tuttavia: l’esigenza della vita è in questo caso […] l’imperativo di sfuggire a una vita senza dignità, umanità e libertà. Così la morte si fa vita, così come la vita sin dalla nascita è già morire. E la negazione all’improvviso si fa positività, sia pure inutile» (p. 124).
———
Immagine di copertina:
Jack Kevorkian, Nearer My God to Thee, olio su tela.




